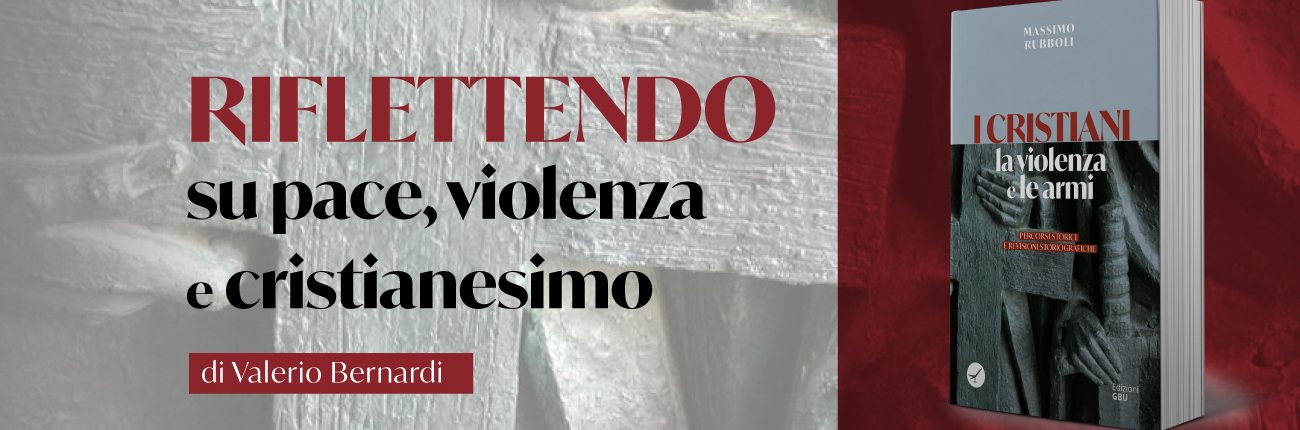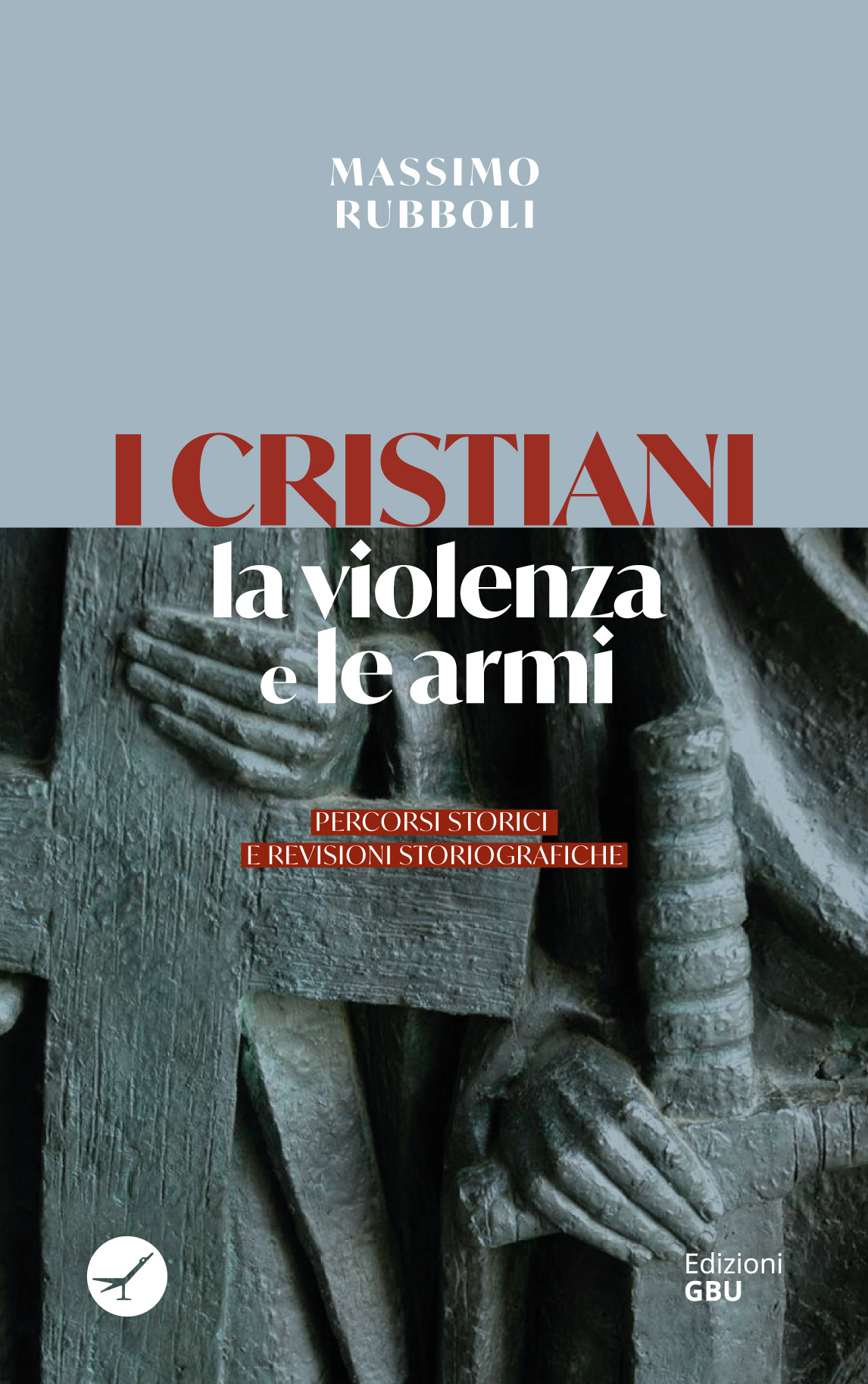Tempo di lettura: 6 minuti
Questi comandamenti, che oggi ti do, ti staranno nel cuore; li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.Te li legherai alla mano come un segno, te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città.
Deut, 6: 6-9
Tra le notizie più diffuse nel nostro Paese negli ultimi giorni, circolano le “anticipazioni” delle Nuove indicazioni Nazionali per le scuole (primaria e secondaria) che, elaborate da un’apposita commissione presieduta dalla pedagogista Loredana Perla, dovrebbero “riscrivere” quelli che saranno i programmi della scuola italiana. Le “novità” ci sarebbero e riguardano soprattutto la “re-introduzione” del latino nella scuola media, la divisione tra storia e geografia, un rafforzamento della storia nazionale e l’introduzione della lettura della Bibbia a scuola.
Dobbiamo subito dire che sino a che non viene pubblicato il testo ufficiale delle Indicazioni non ci possono essere commenti e bilanci definitivi, perché solo quel testo ci permetterà di fare le opportune valutazioni. Però, visto che sia il Ministro Valditara che la prof.ssa Perla (che presiede la Commissione che hanno rivisto le Indicazioni Nazionali), anche nei loro social, hanno convalidato queste anticipazioni, ci sentiamo di fare alcune considerazioni.
Lasciando da parte le polemiche che riguardano latino e divisione tra storia e geografia, volevo fare alcune considerazioni sull’introduzione della lettura del testo biblico a scuola, cosa che per noi evangelici dovrebbe suscitare sicuramente interesse, riservandomi di tornare anche sulla questione della storia nazionale in un altro intervento.
Noi evangelici che viviamo in Italia sappiamo che il nostro Paese, dove la Bibbia (almeno una volta) a partire dagli anni 1960 era quasi sempre presente nelle case degli italiani, era anche un libro scarsamente letto e questo era dovuto a diversi fattori. In primo luogo, siamo stati un paese dove il tasso generale di alfabetizzazione era piuttosto basso fino a settant’anni fa e dove la cultura cattolica popolare e colta non favoriva la lettura del testo biblico, tenendo conto che, sino agli anni 1950 sarebbe stata consentita solo attraverso la mediazione del testo latino e quella del Magistero.
Tutto ciò ha sicuramente portato ad un “analfabetismo” biblico che è molto presente nella nostra società e di cui, in realtà, solo negli ultimi anni ci si è resi forse conto anche da parte dell’opinione pubblica (si veda per esempio il successo, proprio in questi giorni, di un libro come Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo). Basta provare a fare una lezione di filosofia e di storia in cui dovete fare dei riferimenti biblici per comprendere come anche i vostri alunni più brillanti siano totalmente a digiuno della minima conoscenza del testo biblico.
Il dibattito sulla lettura della Bibbia a scuola non è nuovo. Da ormai qualche decennio in Italia vi è un’associazione chiamata Biblia che proponeva l’introduzione dello studio del testo biblico a scuola che è stato sostenuta anche da intellettuali di punta del nostro orizzonte culturale come Umberto Eco ed altri.
La questione ovviamente si è sempre scontrata con un dato da cui non si può prescindere quando si parla di fatto religioso in Italia: in tutte le scuole, infatti, è presente l’insegnamento della religione cattolica che scaturisce dal Concordato (rinnovato nel 1984) con la Chiesa Cattolica che di fatto rende presente questo insegnamento in ogni ordine e grado scolastico. La prima domanda quindi è proprio questa: vi sarebbe una relazione tra lettura della Bibbia e insegnamento della religione cattolica? Se, infatti, lo Stato spende già risorse finanziarie per quest’ora non si dovrebbero cambiare le Indicazioni Nazionali per questi docenti, obbligandoli a soffermarsi di più sul testo biblico? E’ chiaro che la domanda rimane aperta sino a quando non avremo il testo completo dei nuovi programmi proposti. Allo stesso tempo abbiamo una certezza: l’insegnamento della religione cattolica non sparirà per ora dalle scuole, sostituito da un insegnamento di tipo aconfessionale, visto che il Ministero ha appena bandito un concorso per regolarizzare i precari in questa disciplina.
Da quanto si comprende, però, sembra che la lettura di brani biblici nella scuola primaria sarà collegata allo studio dell’epica, quella disciplina in cui anni fa (e ancora oggi) si studiano i poemi omerici, l’Eneide di Virgilio e (così ha affermato il Ministro) le saghe nordiche. In questo contesto ci sembra che siano privilegiati i racconti biblici che diventano delle saghe o che somigliano ai racconti epici (i racconti dei patriarchi, dei re e dei profeti?).
Sicuramente l’idea che vi è dietro ha una sua importanza: si tratta di concetti che qualche decennio furono portati avanti dal critico letterario americano Northorp Frye nel suo celebre libro Il grande codice. In questo testo si sosteneva che il testo biblico è uno dei testi base della letteratura occidentale e in tale senso va studiato da tutti. Queste considerazioni, assolutamente laiche, sono importanti da un punto di vista culturale e se il motivo per introdurre la lettura (io spero che sia questo e non semplice narrazione) dei testi biblici rientra in una operazione di incremento della literacy, sulla falsariga di qualche idea proveniente dagli USA dove la lettura di questi testi dovrebbe portare ad un miglioramento delle capacità di lettura di tutti.
Nelle affermazioni sinora fatte non è chiaro se quest’approccio continuerà nella scuola secondaria, dove, soprattutto negli indirizzi a matrice umanistica (come è il liceo classico) potrebbe anche giocare un ruolo. Questo è quanto abbiamo compreso dell’introduzione della Bibbia a scuola: può darsi che ci sbagliamo perché le notizie rimangono parziali.
Da evangelico le questioni che sorgono sono tante. Pur potendo essere contenti che il testo biblico sia riconosciuto come importante da un punto di vista culturale, ci poniamo una serie di questioni.
In primo luogo una domanda tecnica: chi insegnerà la Bibbia? Leggere il testo biblico come un “grande codice” o come un “testo mondo” (altra definizione data in questi giorni) richiede una serie di competenze che se forse hanno gli insegnanti di religione cattolica che si sono formati, difficilmente hanno gli altri insegnanti. Come si formeranno i futuri insegnanti di Bibbia? Non basta probabilmente neanche chi ha una formazione classica perché l’Antico Testamento non segue le strutture di quella letteratura ed ha una sua tipicità che può essere spiegata solo conoscendo bene l’ambiente del Vicino Oriente antico e di alcune strutture base delle letterature semitiche.
Se possiamo concordare che il testo biblico è un importante testo della cultura occidentale e che merita di avere attenzione nei curricoli scolastici, non dobbiamo dimenticarci che è anche un testo sacro e confessionale, la cui diffusione e divulgazione è stata affidata alle Chiese. Esiste un modo di leggere la Bibbia che sia aconfessionale e che possa così essere introdotto a scuola? Anche su questo possono sorgere dei leciti dubbi. Se è vero che gli esegeti biblici usano tutte le tecniche più avanzate dell’analisi letteraria, solitamente lo fanno per capire il senso del messaggio per i credenti. I due aspetti non sono facilmente scindibili.
Siamo convinti che il libero esame delle Sacre Scritture (prerogativa del mondo evangelico e non di quello cattolico) è stato fondamentale per la diffusione della lettura e della scrittura nel mondo occidentale, ma rimaniamo perplessi che questo principio (quasi del tutto estraneo alla cultura del nostro Paese) possa essere ora assunto in maniera tale da poter così risolvere i problemi di literacy che sembra avere il nostro Paese (dico sembra perché non è chiaro che siano i nostri giovani a non comprendere un semplice testo scritto o la popolazione in genere che è stata già scolarizzata anche in maniera tradizionale e non innovativa).
Pertanto, in maniera del tutto provvisoria, pur potendo comprendere alcune delle ragioni che porterebbero all’introduzione della lettura di brani biblici a scuola, rimaniamo perplessi dal come tutto questo debba essere fatto e su come non debba diventare un processo identitario ma meramente culturale.
La Bibbia, per noi evangelici (ma questo sentimento è anche condiviso dai cattolici) è un libro mondo nel senso che ha come suo indirizzo tutto il mondo e non ha la peculiarità di essere un testo occidentale (pur fondandone la cultura), ma di un testo formatosi nel Medio Oriente che ha sempre avuto pretese universalistiche anche nei passi più identitari per il popolo ebraico.
Rimane un’altra questione che per noi è fondamentale: quanto l’educazione biblica possa essere svolta in un luogo di Stato e quanto invece debba essere di pertinenza delle Chiese e delle famiglie.
Sorvoliamo ovviamente su altre problematiche e ricordiamo due episodi, uno biblico e l’altro storico. Il primo concerne il passo messo come inizio di questo articolo: nel libro di Deuteronomio dopo che Mosé ripete i comandamenti ricorda che la Legge va ricordata e che il compito di ricordarla alle future generazioni spetta alla comunità (quella religiosa ebraica) e alle famiglie. E’ chiaro che stiamo prima dell’esistenza di uno Stato e di scuole formali, ma è un episodio su cui riflettere. La seconda riguarda l’attenzione che all’educazione biblica è sempre stata data dalle Chiese che provengono dalla Riforma. Lutero, non appena iniziò la sua opera di diffusione del Vangelo, comprese subito quanto fosse importante l’istruzione biblica per i bambini: creò il Catechismo e la scuola domenicale per questo all’interno delle attività ecclesiastiche. Riteniamo che proprio per questo il testo biblico e la storia della Riforma ci diano delle indicazioni che vanno forse in direzione forse diversa da quella che è la proposta, di cui pur apprezziamo nelle intenzioni e su cui ci riserviamo di dare un giudizio finale solo a testo pubblicato.
Valerio Bernardi – DIRS GBU
L’articolo Bibbia a scuola? Parliamone proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/bibbia-a-scuola-parliamone/