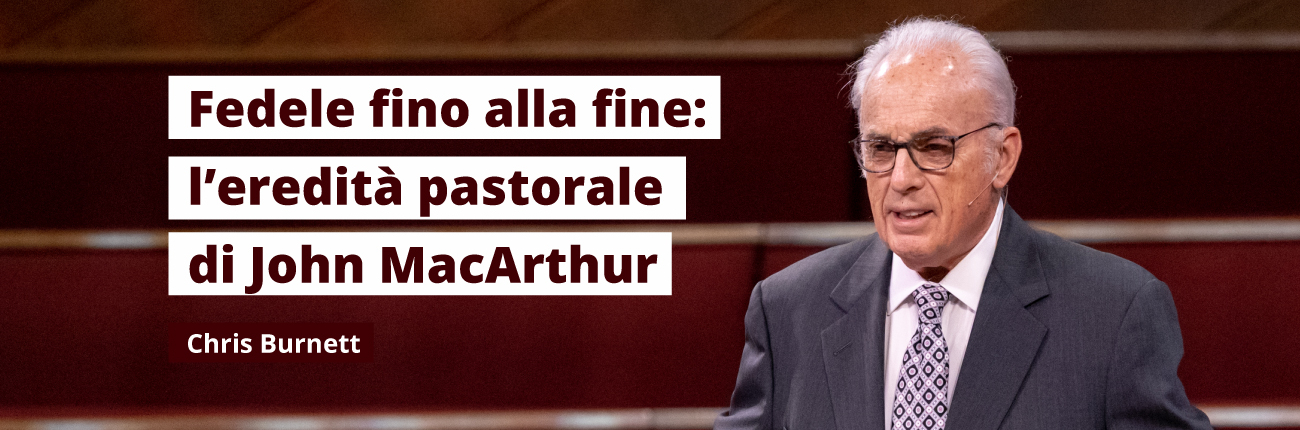
di Chris Burnett
(Los Angeles, California)
Il 14 luglio 2025, il pastore John MacArthur è stato chiamato in gloria all’età di 86 anni, dopo due anni segnati da complicazioni cardiache e polmonari. Per 56 anni ha guidato fedelmente la Grace Community Church a Los Angeles, in California, plasmando il panorama evangelico conservatore moderno attraverso la sua predicazione e leadership. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca che ha profondamente influenzato l’esposizione biblica e l’evangelicalismo conservatore negli Stati Uniti e nel mondo. Il pastore John ha lasciato la moglie Patricia, sposata nel 1963, quattro figli, quindici nipoti e nove pronipoti.
La storia della mia famiglia con il pastore John copre cinque decenni e tre generazioni, segnata da tappe fondamentali. Mio padre si convertì da adolescente nella chiesa del padre di John, quando John era ancora semplicemente conosciuto come “Johnny.” Fu lui a battezzare mia madre quando, a diciotto anni, lasciò il cattolicesimo romano per seguire Cristo. Quando ero neonato, prese tra le braccia me e mia sorella gemella per dedicarci al Signore. Anni dopo, tornato da sette anni di missione in Italia, divenni studente nel suo seminario, The Master’s Seminary. In quegli anni, John prese in braccio mio figlio più piccolo per pregare con lui prima di un intervento al cuore e consolò personalmente mia moglie Erma quando suo fratello morì di cancro. In mezzo secolo alla Grace Community Church, la nostra famiglia ha condiviso numerosi momenti speciali con il pastore John, che ci hanno sempre ricordato che, pur essendo uno dei più noti insegnanti della Bibbia in America, desiderava essere conosciuto soprattutto come un amico.
È un tempo di dolore per la nostra famiglia e per tutta la Grace Church, ma anche un’opportunità per riflettere su ciò che John MacArthur ha rappresentato per noi e per il mondo. Il seguente riassunto della sua vita, del suo ministero, delle sue convinzioni e del suo carattere vuole mostrare come la sua influenza continuerà a risuonare nell’eternità.
Vita e Ministero
John Fullerton MacArthur Jr. nacque il 19 giugno 1939, quinta generazione di una straordinaria linea di predicatori che risale al Canada e alla Scozia. Suo padre fu pastore battista ed evangelista itinerante, noto per il suo ministero tra le celebrità di Hollywood e per il programma radiofonico di grande impatto Voice of Calvary.
Nel febbraio 1969, a 29 anni, John fu chiamato a servire nella Grace Community Church di Sun Valley, California. La sua prima predicazione domenicale fu tratta da Matteo 7:21: “Non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, entrerà nel regno dei cieli; ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.” Con questo messaggio inaugurale, John mise subito in discussione la genuinità della fede professata e stabilì il tono di tutto il suo ministero: una predicazione esaustiva, versetto per versetto, fondata su circa 30 ore settimanali di studio accurato della Scrittura.
L’ampia richiesta delle sue predicazioni portò alla nascita del ministero radiofonico Grace to You, con il motto: “La verità di Dio, un versetto alla volta.” Alla fine della sua opera, la biblioteca gratuita su gty.org contava oltre 3.300 sermoni, che coprono ogni versetto del Nuovo Testamento e buona parte dell’Antico. Per grazia di Dio, il sito ha recentemente superato i 225 milioni di download gratuiti.
Il pastore John è stato giustamente riconosciuto come uno dei più influenti predicatori esegetici della sua generazione. La sua predicazione era segnata da autorità biblica, chiarezza del testo, comunicazione coinvolgente e amore per Gesù Cristo. Ma la vera forza non stava soltanto nei metodi interpretativi che applicava, bensì nell’evidente realtà che Dio gli aveva donato un carisma unico per insegnare la Parola. Quel dono, ricevuto dal Signore, aveva lo scopo di farci “crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo” (2 Pietro 3:18).
L’eredità lasciata da MacArthur sul piano editoriale e formativo è immensa. Ha scritto quasi 400 libri e guide di studio, tradotti in più di venti lingue. Tra i più noti, la Bibbia di studio MacArthur, con 20.000 note specifiche per versetto e oltre due milioni di copie vendute, e la collana di commentari sul Nuovo Testamento in 34 volumi—ora affiancata da una serie in sviluppo sull’Antico Testamento, per continuare a formare pastori in tutto il mondo.
Nel 1985 fu nominato presidente del The Master’s College (oggi The Master’s University), e l’anno seguente fondò The Master’s Seminary, servendo come presidente e poi come cancelliere per oltre 35 anni. Attraverso queste istituzioni e The Master’s Academy International (TMAI), più di 10.000 uomini sono stati formati al ministero pastorale in 41 nazioni. Ho il privilegio di servire con entrambe e di vedere una nuova generazione di fedeli insegnanti della Bibbia crescere ed essere inviati per adempiere la Grande Commissione (Matteo 28:18–20).
La visione di John per un ministero fedele continua ancora oggi attraverso la Shepherds’ Conference, ospitata ogni anno presso la Grace Community Church e il Master’s Seminary. All’ultima edizione, oltre 5.000 pastori e leader provenienti da tutti i 50 stati americani e da 70 nazioni si sono riuniti, desiderosi di essere nutriti dalla Parola di Dio per poter nutrire a loro volta il gregge nei propri contesti.
Convinzioni e Controversie
L’intero ministero di MacArthur si fondava su una convinzione incrollabile: la Scrittura è pienamente sufficiente per ogni verità spirituale, capace di offrirci “tutto ciò che riguarda la vita e la pietà” (2 Pietro 1:3). Difese con chiarezza il metodo storico-grammaticale, affermando che la Bibbia deve essere interpretata in modo semplice, letterale e conforme all’intento originale dell’autore.
Da questa base scaturirono molte delle sue posizioni più distintive. MacArthur sostenne la creazione letterale in sei giorni, rifiutò le teorie evoluzionistiche e mise in guardia contro l’influenza della psicologia secolare nella consulenza pastorale, sottolineando i pericoli di affidarsi a modelli umani che possono distorcere la verità rivelata. Rigettò anche la visione della Teologia dell’Alleanza secondo cui la chiesa avrebbe sostituito Israele, affermando invece che le promesse dell’Antico Testamento rivolte a Israele si realizzeranno letteralmente nel futuro.
Nel 1988 pubblicò Il Vangelo secondo Gesù (Edizione Coram Deo), un’opera che suscitò un ampio dibattito nel mondo evangelico. In essa sosteneva che la vera fede comporta sottomissione a Cristo come Signore, e non solo come Salvatore. Alcuni critici lo accusarono di confondere fede e opere, mentre teologi come J. I. Packer lo sostennero, riconoscendo in quelle parole la continuità con la dottrina storica della Riforma.
MacArthur espresse anche una forte opposizione al movimento carismatico, che considerava una deviazione dal cristianesimo biblico. Da cessazionista convinto, sostenne nei suoi libri I carismatici (1992, Ed. Centro Biblico) e Strange Fire (2013) che i doni dello Spirito manifestati nell’epoca del Nuovo Testamento fossero cessati con la fine dell’era apostolica, e riteneva molte delle manifestazioni contemporanee un travisamento dell’opera dello Spirito Santo.
Durante la pandemia di COVID-19, guidò con fermezza la Grace Community Church nella riapertura, nonostante le restrizioni imposte dalle autorità. Affermava con decisione che la chiesa locale è essenziale per la vita cristiana. La battaglia legale che ne seguì si concluse con una vittoria significativa a favore della libertà religiosa, raccontata nel documentario The Essential Church, che ripercorre la sua leadership coraggiosa in un tempo di forte pressione pubblica.
L’Eredità di un Pastore Fedele
Chi ha conosciuto personalmente MacArthur ha spesso notato quanto il suo carattere mite contrastasse con la forza con cui predicava dal pulpito. Nella vita di tutti i giorni, molti di noi lo ricordano come un uomo gentile, sempre rispettoso, e profondamente dipendente da Cristo. Il suo cuore pastorale si rendeva visibile in tanti piccoli gesti: visite inaspettate in ospedale, colloqui personali, e atti di generosità sincera. Il suo impegno era instancabile — 30 ore settimanali di studio, predicazioni multiple ogni domenica, insegnamento durante la settimana alla chiesa, all’università e al seminario, oltre a numerosi interventi mediatici e conferenze — molti dei quali continuano a circolare ancora oggi online.
Tra tutte le sue influenze, credo che la più duratura sia questa convinzione profonda che ci ha trasmesso: che la Scrittura è lo strumento scelto dallo Spirito Santo per attirare le anime a Cristo e trasformarle secondo la Sua immagine.
Sono grato che l’influenza di MacArthur sia arrivata anche in Italia, dove il suo impegno per la predicazione versetto per versetto ha messo radici grazie a numerose traduzioni fedeli e iniziative pastorali.
Ciò che è cominciato con un uomo determinato a “liberare la verità di Dio, un versetto alla volta,” è diventato un movimento globale. Il messaggero è tornato a casa, ma la Parola che ha proclamato continua la sua corsa — attraverso la voce di espositori fedeli, fino al giorno in cui ogni popolo, lingua e nazione si prostrerà davanti al trono per adorare l’Agnello
Chris Burnett insegna presso The Master’s Seminary e serve in ambito accademico con The Master’s Academy International, che forma pastori in 85 paesi attraverso 20 scuole.
Vive a Los Angeles con sua moglie Erma e i loro tre figli.
Foto di copertina: David Torres
L’articolo Fedele fino alla fine: l’eredità pastorale di John MacArthur proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/fedele-fino-alla-fine-leredita-pastorale-di-john-macarthur/



