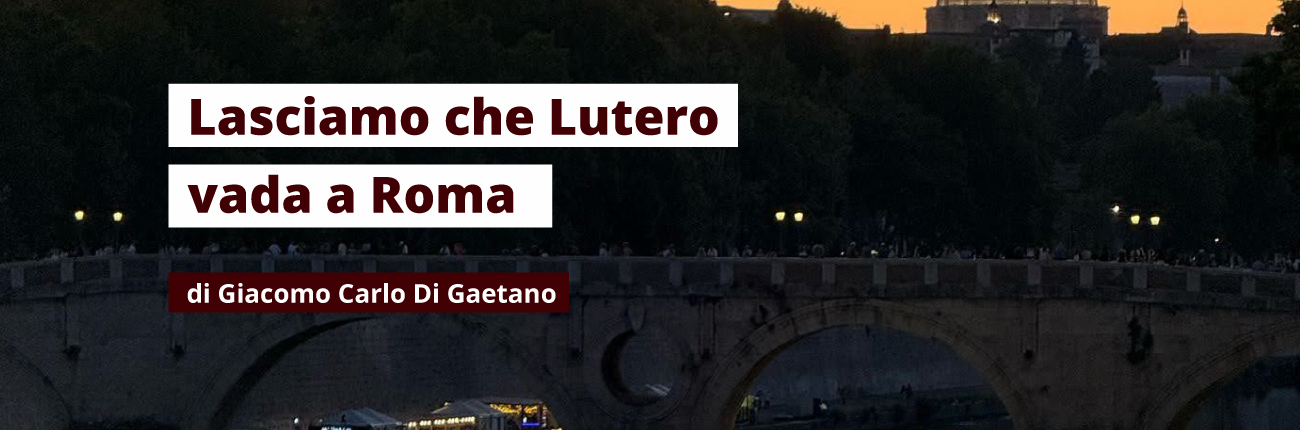
di Giacomo Carlo Di Gaetano
Si stima che in questo anno giubilare la città di Roma sarà raggiunta e visitata da più di 30 milioni di visitatori: pellegrini, turisti, avventori, etc. Uno dei momenti più caldi sarà (è stato) sicuramente quello del Giubileo della Gioventù (28 luglio – 4 agosto).
Non è una novità, questo è il destino di Roma.
Il Giubileo ha sempre aggiunto a questo itinerario un alone sacrale, associando in tal modo Roma ai grandi santuari e luoghi di pellegrinaggi disseminati in tutto il mondo.
La presenza di questi luoghi (il lettore della Bibbia ricorderà la perplessità di una donna samaritana su due di essi, relegati nella provincia di Palestina – Gerusalemme e/o Samaria, Gv 4) sono una rappresentazione plastica di quell’anelito all’incontro con il divino che ha sempre animato gli esseri umani.
Per i cristiani che si sono fatti condizionare dalle parole di Gesù in Giovanni 4 sull’avvento di un’ora in cui l’incontro con Dio poteva fare a meno della geografia (bisogna adorarlo in spirito e verità!) è iniziato un lungo tormento interiore e una lunga riflessione “iconoclasta”. Nessuno nella storia ha mai fatto a meno di qualche luogo che sebbene spoglio di qualsiasi aura sacrale, ha però assunto un rilievo simbolico in grado di condizionare sempre e nuovamente la spiritualità. Si pensi a Ginevra nell’universo calvinista.
Anche il monaco agostiniano Lutero andò a Roma (nell’inverno del 1510–1511)! In un documentato viaggio di tipo amministrativo il padre della Riforma accompagnato da un suo confratello fece questo viaggio e soggiornò nella capitale per alcuni mesi. Tutte le biografie di Lutero ne parlano. Quelle da me consultate, dalle classiche di Bainton e Miegge (in italiano) a quelle più recenti di Adriano Prosperi e Silvana Nitti dedicano un certo numero di pagine a questo evento che ha suscitato la mia curiosità fin dall’inizio di questo anno santo e fin dalla registrazione delle iniziative messe in campo dagli evangelici per intercettare e in qualche modo condizionare questo gigantesco fenomeno del viaggio a Roma.
Le biografie sono concordi nel rilevare il silenzio o quanto meno la sottigliezza delle fonti relative a questo viaggio. Ci sono i ricordi dello stesso Lutero affidati ai suoi Discorsi a tavola (Tischreden) e qualche riferimento in altri scritti molto lontani nel tempo; e qualche legenda fiorita all’indomani della morte di Lutero.
La più famosa è quella che vuole Lutero che riceve l’illuminazione sulla giustificazione per fede in cima alla scala santa da lui risalita in ginocchio e secondo le modalità della spiritualità medievale.
Forse il suo commento più spendibile da un punto di vista dei significati posteriori è questo: «Anch’io, come uno stupido, portai cipolle a Roma e ne portai indietro aglio». La Nitti suggerisce che lo scambio, grazie alle sue lontane origini contadine, era considerato estremamente svantaggioso (Nitti, p. 60). Lo svantaggio stava naturalmente non solo nel fallimento del compito amministrativo per il qual era stato inviato ma anche per alcune delusioni avute nel suo soggiorno nella capitale religiosa, soprattutto relativamente al modo di celebrare la messa e la scarsa considerazione che il sacramento aveva nella bolgia romana. Proprio la Nitti segnala che, al di là della pervadente corruzione ecclesiale, di cui Roma era un concentrato, ciò che rimase impresso nel monaco tedesco fu la disponibilità e la facilità del perdono, da ricercare, procurarsi, ottenere con i più svariati e creativi modi, dal giro delle sette chiese, alla visita a una reliquia, etc.
«Ero un così pazzo santo (so ein toller Heilig) che correvo per tutte le chiese e le cripte, e credevo tutte le bugie e le invenzioni che raccontavano. Io pure ho detto una messa, o anche dieci, a Roma, e quasi mi dispiaceva che mio padre e mia madre fossero ancora in vita, perché li avrei volentieri liberati dal purgatorio con le mie messe e con altre più eccellenti opere e preghiere» (Miegge p. 75).
Questo perdonificio «fece dubitare anche lui». La principale conseguenza della visita a Roma non fu dunque la critica alla corruzione quanto l’acuirsi di domande interiori che esplosero da lì a qualche tempo con il suo studio sulla Lettera ai Romani e la scoperta della “giustificazione”.
«I suoi dubbi, a Roma come prima a Erfurt e dopo a Wittenberg, non erano l’inizio di una battaglia contro la gerarchia e il papa; erano il suo modo di vivere la fede …» (Nitti, p. 63).
Sta tutto qui in questa tensione tra il sacro e l’interiore, tra l’esposizione ai simboli e allo spettacolo della spiritualità istituzionale e la ricerca di Dio nella Bibbia e, da buon agostiniano, nell’interiore, che si gioca il significato di questa piccola parentesi romana nel contesto più ampio della stagione della Riforma. E sta anche qui la possibilità di riprendere questo episodio per avere ulteriori chiavi di lettura per la contemporaneità.
Questo è anche il dibattito che anima i biografi (relativamente come sostiene Prosperi, p. 52) e ben riassunto dalla rilevazione di Bainton: «quel che egli vide e quel che non si curò di vedere ne illumina la personalità» (p. 22, corsivo aggiunto)
Per Miegge (pp. 76–77):
«le quattro settimane passate a Roma ebbero per il giovane monaco, ardente e ingenuo, l’effetto di una sconsacrazione». E il silenzio viene così interpretato: «Furono forse soltanto fugaci impressioni di malessere dovute all’oscurarsi di un ideale forse eccessivo, che dovevano precisarsi in seguito, liberando il Riformatore dallo scrupolo di far torto, con la sua azione rivoluzionaria, alla città santa della sua giovinezza» (p. 77)
Adriano Prosperi dal canto suo (p. 63) precisa che Lutero non era un moralista; pensava sd altro: si chiedeva se la Scala Santa fosse davvero quella su cui Gesù aveva posato i pieri. La Scrittura era la sua enciclopedia, il suo mappamondo. (p. 63)
Ma che ne è della contemporaneità?
Questo episodio sicuramente non detta un paradigma di interazione tra evangelici e cattolici (in questo campo se ne è sempre alla ricerca di uno) ma sicuramente segnala una precauzione e un interrogativo al quale facciamo bene a non rispondere, aspettando … come fa un lettore di una biografia di Lutero: aspettando il capitolo successivo (i più eloquenti sono quelli di Prosperi e di Miegge: – [Prosperi, Il dottor Lutero e il problema della coscienza, pp. 65–82]; [Miegge, La crisi, pp. 79–101]).
Perché un cattolico, convinto o meno che sia, da Occidente o da Oriente (grazie alla macchina organizzativa delle diocesi) non dovrebbe recarsi a Roma e attraversare la Porta Santa? Magari è fortunato e si ritrova a Roma proprio mentre, morto il Papa, c’è il Conclave che ne sta eleggendo un altro (un intervistato durante il Conclave che ha eletto Leone XIV: siamo a Roma per il weekend, speriamo di vedere la fumata bianca prima di ripartire …).
Viene riproposto davanti a noi, in maniera abbastanza provvidenziale, il dilemma del giovane Lutero, vale a dire la ricerca di un qualcosa che si ritiene possa essere accordato da uno spettacolo imponente di un’istituzione che si ammanta di sacralità (sfumando tutte le naturali e ataviche problematiche, incluso gli scandali, che tutte le istituzioni umane si portano con sé, da che mondo è mondo, a Roma come a Canterbury o Westminster). Bainton lo dice chiaramente: finché il giovane Lutero credeva che “la chiesa avesse efficaci mezzi di grazia”.
Sta tutta qui la possibilità del vangelo (non degli evangelici): far esplodere la tensione tra coscienza è istituzione, tra libertà e formalismo, riuscire a canalizzare quella spinta a guardarsi dentro che pure un agostiniano come l’attuale Papa dovrebbe conoscere bene, al punto tale che la cita in un passaggio della sua omelia a Tor Vergata (il 3 agosto). Che cosa si porteranno dietro il milione di giovani convenuti a Roma. Ci auguriamo per loro tanta forza e tante cose positive come auspicano tutti gli osservatori, anche ecclesiastici, che hanno goduto dei numeri della partecipazione (un po’ come gli organizzatori di una protesta sindacale o di una kermesse politica).
Hanno incontrato veramente il Cristo risorto come lasciava intendere l’incipit dell’omelia papale che è partita dall’episodio dei due discepoli sulla via di Emmaus per poi perdersi nei meandri della caducità umana (i fili d’erba) segnata dal consumismo e da altri mali del secolo?
Non ritroviamo in quella omelia, e lo diciamo sommessamente, l’afflato espositivo che anima un lettore e un espositore dei vangeli (quell’afflato che condizionerà il Lutero tornato dall’Italia). Ma è proprio questo che ci lascia sperare: l’ossimoro grammaticale tra un’istituzione che si concepisce prosecuzione dell’incarnazione e che relega Gesù Cristo ai riti penitenziali e sacramentali e una coscienza che cerca la “parola di Dio” unico luogo in cui Cristo continua a vivere e permanere (1 Pietro) e unica grazia che può penetrare nelle crisi che incontreranno il milione di giovani, così come le incontrano tutti gli esseri umani.
Dunque?
Lasciamo che Lutero vada a Roma, che cerchi la pace interiore, che cerchi Cristo. Prima o poi tornerà a Wittenberg e lì ci sarà qualcun altro ad attenderlo: il vangelo di Gesù Cristo. Facciamoci trovare lì come testimoni del vangelo … e non come discepoli di Lutero (sic!).
Letture
Roland H. Bainton, Lutero, ed. RCS, Corriere della Sera, 2006;
G. Miegge, Lutero. L’uomo e il pensiero fino alla Dieta di Worms (1483–1521), Claudiana, Torino, 4 ed., 2003;
A. Prosperi, Lutero. Gli anni della fede e della libertà, Mondadori, Milano, 2017;
S. Nitti, Lutero, Salerno Editrice, Roma, 2017.
L’articolo Lasciamo che Lutero vada a Roma proviene da DiRS GBU.

