La Via Dolorosa vs Wall Street
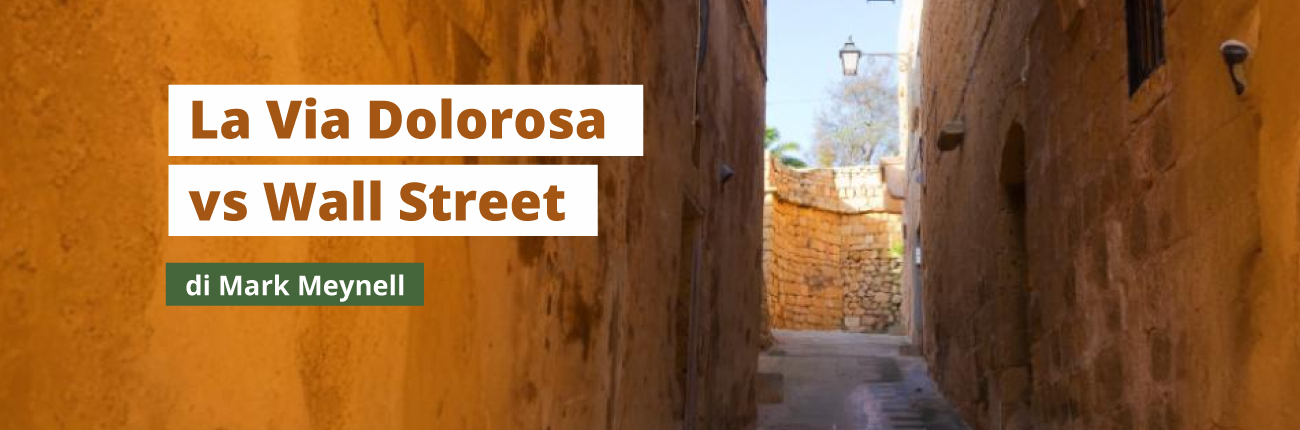
di Mark Meynell
(Mark Meynell sarà il relatore al 18° Convegno Studi del GBU (5-8 dicembre, Montesilvano -PE- “Vivere e confrontarsi con il dubbio“)
Il brano è tratto dal libro dell’autore, che sarà presentato al Convegno, dal titolo Un deserto di specchi. Tornare a credere in un mondo segnato da dubbi, sospetti, cinismo e scetticismo
Al pari di ogni nuovo movimento, religioso o di altra natura, i primi cristiani idearono un nome per la loro nuova fede. Era nota semplicemente come «la via», parola comune che poteva voler dire indifferentemente “sentiero” oppure “strada” (At 9:2; 19:23; 24:14). Fu una scelta ingenua. Ogniqualvolta facevano agli altri degli appelli perché credessero in Gesù, tutto quello che stavano facendo era invitarli a unirsi a loro nella stessa strada che stavano percorrendo. Di certo non v’era alcun senso di superiorità o di sufficienza, rendendo chiaro che al pari della vita, anche l’esperienza della fede in Cristo è un viaggio. Nessuno sulla via poteva asserire di avercela fatta, di essere arrivato. La cosa aveva pertanto una sua forza attrattiva, la cui migliore sintesi è l’adagio per definire l’evangelismo: si tratta «semplicemente di un pezzente che mostra a un altro pezzente dove trovare il pane».
Per vedere come il rapporto della chiesa ufficiale con il potere pubblico cambiò rispetto ai primi decenni della via, dobbiamo tornare all’imperatore romano del quarto secolo considerato nel capitolo 7 (Qualcuno di cui fidarsi. Il potere in mano sicure).
Costantino emerse vittorioso da una lotta per il potere imperiale. Calcolò spregiudicatamente che un Cristianesimo assurto al rango di religione ufficiale dell’Impero avrebbe calzato a pennello ai suoi bisogni politici. Analogamente, i cristiani riconobbero quanto fosse vantaggioso sostenerlo contro i suoi rivali, per nulla empatici nei confronti della via[1]. Da allora, come osservato da Graham Tomlin, «il Cristianesimo nel mondo occidentale ha cercato d’influenzare la società da una posizione di forza»[2]. Fu l’inizio di quello che divenne noto come Cristianità. Naturalmente, si evolse in un lungo periodo di tempo ma l’editto di Costantino ebbe conseguenze memorabili.
L’imperatore aveva fretta di giungere a una decisione definitiva sulla cristologia, non necessariamente perché avesse forti convinzioni in un senso o nell’altro ma perché la confusione remava contro i suoi programmi politici. Di fatto, rimproverò entrambi gli uomini al centro del dibattito (Ario e il vescovo Alessandro di Alessandria) per essere causa di tanti problemi. Così, nel 325 d.C., convocò a Nicea circa milleottocento vescovi da tutto il mondo per il primo grande concilio della chiesa, anche se forse riuscirono ad arrivarci solo in trecento. La successiva professione del concilio (nota come Credo niceno) proclamò solennemente la natura congiuntamente umana e divina di Cristo. Lungi dall’essere un’imposizione del potere imperiale, questo fu un esempio di come i cristiani misero ordine in casa loro su un tema di estrema importanza.
I veri problemi, in realtà, sopraggiunsero dopo. Una cosa era sconfessare le posizioni di Ario (secondo cui Gesù sarebbe stato soltanto umano e non divino) in quanto incompatibili con la fede cristiana; c’era in questa posizione una contraddizione fondamentale. Altra cosa però fu l’esiliò da parte di Costantino dei due vescovi ariani che avevano votato contro il riconoscimento della divinità di Gesù.
Il rapporto fra chiesa e stato risultò così per sempre compromesso.
Da allora è stata una strada a doppio senso. La chiesa si accorse della scorciatoia offerta dal facile accesso ai corridoi del potere per la realizzazione dei propri obiettivi. Anche a Costantino conveniva: tornava utile l’asserzione, da parte della chiesa, secondo cui la sua vittoria doveva essere stata opera della divina provvidenza. Con questo non si vuole negare che debba essere stata davvero la provvidenza divina a produrla (questo è un corollario della fede in un Dio sovrano). Tutt’altra cosa, però, è insinuare una legittimazione, da parte della divina provvidenza, di ogni avventura di un sovrano, non più di quanto votare per un candidato significhi sottoscrivere tutto quanto quel candidato fa mentre è al potere.
Paolo, per citarne uno, è molto bravo a capovolgere quest’idea. Asserisce polemicamente che le autorità del mondo sono stabilite da Dio e dunque si dovrebbe ubbidire alla legge (Rom 13:1–7). Tutto questo però implicava una sua personale approvazione di tutto quanto fatto o promosso da Roma? No di certo! Inoltre, che cosa potrebbe esservi di più politicamente sovversivo dell’asserzione secondo cui Gesù è il Signore (1 Cor 12:3)? Fin dall’inizio, dunque, Paolo proclama l’esistenza di chiari limiti all’ubbidienza civile. Se mai lo stato cercasse di calpestare la supremazia di Cristo, la disubbidienza non sarebbe soltanto consigliabile; sarebbe obbligatoria. Non è mai all’ordine del giorno se Gesù sia dalla parte di un certo candidato, una certa causa o un dato credo. Ben più importante è se loro siano o meno dalla sua. Ecco perché è sempre preoccupante quando un gruppo, uno stato o anche, mi sia consentito azzardare, una denominazione ecclesiastica, rivendica il possesso di un mandato esclusivo per il cielo. Gesù non avrebbe mai potuto essere comunista, capitalista, conservatore, liberale, modernista o postmodernista, femminista, relativista, individualista, democratico o imperialista, monarchico o repubblicano. Scegliete pure la vostra causa; Gesù non ne fa parte. Il ché, però, non significa che non ci siano in alcune o anche in tutte queste idee, degli aspetti in qualche modo coerenti con una visione del mondo cristocentrica (tutti aspetti di cui, nel corso dei secoli, i cristiani sono stati annoverati fra i promotori).
Da allora, sotto molte forme culturalmente diverse, la chiesa si è incamminata lungo un pericoloso sentiero politico. Più i leader cristiani sono stati vicini al potere costituito, meno il loro ministero è risultato profetico. Non che la signoria di Cristo non abbia risvolti nella sfera politica. Se davvero Gesù è il re dei re (p.es., 1 Tm 6:15; Ap 19:16), ogni altra autorità è inevitabilmente rimpicciolita e relativizzata. Non desta stupore la quantità di megalomani che hanno odiato Cristo.
La cautela verso il potere imperiale non è comunque una giustificazione per silos cristiani. Tutt’al contrario. La signoria di Cristo dovrebbe ispirare e influenzare profondamente l’azione in tutti gli ambiti di vita. Martin Lutero applicò esplicitamente l’inno cristologico della Lettera ai Filippesi al modo con cui i principi tedeschi avrebbero dovuto governare: «Il principe svuoti pertanto sé stesso del proprio potere e della propria supremazia nel suo cuore e si preoccupi dei bisogni dei suoi sudditi come se fossero i suoi bisogni. Questo, infatti, è quanto Cristo ha fatto per noi e questa è una vera opera d’amore cristiano»[1]. Eppure, nemmeno Lutero riuscì a percorrere con coerenza questo difficile sentiero. Troppo spesso la chiesa ha consentito alla sua missione di essere indistinguibile da quella dello stato, invece di proclamare la verità al potere anche quando farlo avrebbe potuto minacciare i suoi privilegi. Dopotutto, Gesù fece proprio questo quando fu interrogato da Pilato.
Come potrebbe non essere questa la ragione per cui oggi si fa di tutt’erba un fascio fra la chiesa e ogni altra istituzione umana? Le persone nutrono il comprensibile sospetto che la ciesa abbia agito proprio come ogni altra istituzione. Avendo goduto per secoli di uno status privilegiato in Occidente, grazie al quale ha spesso dominato sugli altri e a volte li ha soggiogati, una cosa, così come ipotizzato da Graham Tomlin, è certamente essenziale: la chiesa deve ripensare «la sua nozione di potere e il modo con cui opera, se vuole giocare un ruolo significativo in questo mondo post–autoritario»[2].
Quest’appello non è motivato da un cinico pragmatismo ma dal desiderio di ritrovare l’antico modello di potere autenticamente cristiano, nello sforzo al tempo stesso di mantenersi fedeli a Cristo e di offrire a un mondo dominato da isolamento e diffidenza una vera alternativa al deserto di specchi. È un appello ai credenti perché percorrano la via e chiamino altri a unirsi loro e fare lo stesso. Questo cammino non è la strada del potere e del successo ma l’impervio sentiero del sacrificio e dell’amore. Quando Gesù ha chiamato gli altri a seguirlo prendendo una croce (Mc 8:34), non voleva dire che i suoi discepoli dovessero morire per il peccato; si limitò a preconizzare l’esperienza dell’incomprensione e del disprezzo da parte del mondo in cui i discepoli sarebbero stati accomunati a lui.
A Gerusalemme c’è ancora una strada di nome Via Dolorosa, in quanto ritenuta la strada lungo la quale Gesù s’incamminò con passo malfermo verso la crocifissione È questa la strada lungo cui la chiesa deve incamminarsi. Invece, siamo tanto attratti da altre strade per i nostri modelli di potere. Sotto l’Impero britannico, la chiesa è stata spesso simile alle due autorità londinesi ubicate a Whitehall (sede del Governo) e sulla strada il cui nome presenta qualche curiosa eco biblica, Threadneedle Street sede della Banca dInghilterra [Il nome è composto dalle parole inglesi per filo e ago, forse in quanto anticamente sede di fabbriche di aghi; l’autore fa evidentemente riferimento al monito di Gesù in Mt 19:24 e riff., ndt].
Gli influssi odierni provengono più verosimilmente da Pennsylvania Avenue, Hollywood Boulevard, Wall Street e Madison Avenue. Le ultime mode in politica, intrattenimento, economia e management o marketing e comunicazioni plasmano probabilmente il modus operandi odierno della chiesa non meno di quanto il paternalismo imperiale britannico lo facesse più o meno un secolo fa.
Non intendo ignorare le numerose e felici eccezioni a questo trend o insinuare che la chiesa non abbia nulla da imparare da queste «strade». Il punto è semplicemente: da dove vengono i programmi, i metodi e il carattere della chiesa? In definitiva, tutte queste strade seguono il percorso opposto a quello della Via Dolorosa. Come la storia della chiesa insegna, ogniqualvolta la chiesa se n’è dimenticata, il messaggio di un re crocifisso chino a lavare i piedi è impercettibilmente ma inesorabilmente messo ai margini.
[1] Citato in R. Haydon Mitchell, Church, Gospel, and Empire: How the Politics of Sovereignty Impregnated the West, Wipf and Stock, Eugene, 2011, p. 183.
[2] G. Tomlin, Power of the Cross, op. cit., p. 312.
[1] R. Stark, Rise of Christianity, op. cit., p. 11.
[2] G. Tomlin, Power of the Cross, op. cit., p. 31.
L’articolo La Via Dolorosa vs Wall Street proviene da DiRS GBU.


