Perché, Signore, nascondi il tuo volto?
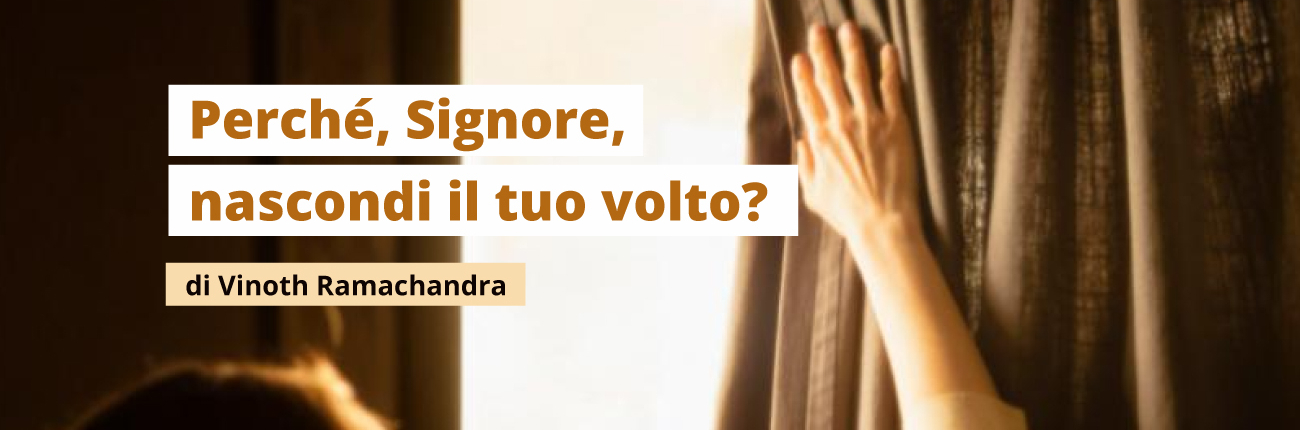
di Vinoth Ramachandra
(Il riso di Sara. Dubbio, lacrime e speranza cristiana, Edizioni GBU, 2025 – Collana Il duplice ascolto)
«Chi crede di credere in Dio, senza però passione nel suo
cuore, senza angoscia nella sua mente, senza incertezze,
senza subbi e perfino, a volte, senza disperare, crede solo
nell’idea di Dio, non in Dio stesso» (M. de Unamuno)
«Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia
ascolto? Io grido a te: “Violenza!” e tu non salvi. Perché mi
fai vedere l’iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? … (Abacuc)
Le parole di Abacuc sono state costantemente sulle mie labbra durante la sanguinosa guerra civile dello Sri Lanka iniziata nei primi anni ‘50 del XX secolo e giunta alla sua brutale conclusione soltanto nel 2009. Quella iniziata negli anni ‘50 dalla minoranza tamil del nord come una legittima battaglia per i diritti civili, è sfociata poi nella violenta pretesa di uno stato tamil separato ed è rapidamente degenerata in un’incessante spirale di vendette dominata dalla legge del taglione. Più di centomila persone hanno perso la vita; non si contano quanti, rimasti senza casa, sono fuggiti dal paese come rifugiati.
Com’è normale in tali conflitti violenti, sono state commesse terribili atrocità e spaventose violazioni dei diritti umani sia dai guerriglieri separatisti tamil sia dall’esercito regolare. Nessuna delle rimostranze all’origine della guerra è ancora stata presa in considerazione né i responsabili di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani hanno dovuto rispondere alla giustizia. Lo Sri Lanka è solo uno dei tanti paesi, spesso ricchi di bellezze naturali e forti di una nobile eredità culturale e religiosa, rovinati da politici corrotti e incapaci e da nazionalisti religiosi assetati di potere. Ci sono anche numerose «guerre dimenticate»; se ne combattono di continuo in ogni angolo del mondo ma raramente se ne dà notizia nei canali di news internazionali, per non parlare dei social.
Messi in ginocchio dal conflitto, questi stati sono spesso ricchissimi di risorse, cosa che ha indotto alcuni economisti dello sviluppo a parlare di questi paesi definendoli affetti dalla «maledizione delle risorse». Il combinato di una governance debole e di una grande abbondanza di risorse naturali, promessa di un veloce arricchimento a chi ne controlli la produzione e l’esportazione, è una delle principali cause di violenti conflitti. I diamanti in Angola e Sierra Leone, la legna e i diamanti in Liberia, le pietre preziose in Afghanistan, rame, oro, cobalto e legna nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati tutti al centro di guerre civili. La miniera di Grasberg nella Papua occidentale, la più grande miniera d’oro nonché seconda miniera di rame al mondo, è posseduta dalle società minerarie Freeport McMoran e Rio Tinto, in una delle regioni più povere dell’Indonesia, al momento testimone della nascita di un movimento di guerriglieri separatisti. L’Angola vanta il secondo posto in Africa per estensione dei suoi giacimenti di petrolio, nonché il quarto al mondo per estensione dei suoi giacimenti di diamanti. La sua enorme ricchezza naturale è stata utilizzata per alimentare una guerra civile dove, fra il 1975 e il 2002, un milione di persone sono rimaste uccise o mutilate, mentre altri quattro milioni sono sfollati all’interno del paese. Tre anni dopo la fine della guerra si è classificato 160° su 177 paesi nell’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, con un’aspettativa media di vita di quarant’anni.
Il costo complessivo di tali conflitti non può essere colto dalle sole statistiche (i cui dati, comunque, sono spesso molto meno affidabili in paesi dove sia in corso un violento conflitto). I costi umani immediati, per quanto enormi, rappresentano solo una minima parte del prezzo pagato da questi paesi alla guerra. In conflitti di lunga durata, intere generazioni di bambini e giovani sono oppresse dagli effetti della guerra. Famiglie e comunità lasciano in eredità ai posteri il trauma degli abusi sessuali, dei saccheggi e delle morti violente. Le devastazioni degli habitat naturali e i blocchi nella produzione di cibo e nei mercati locali portano a una diffusa malnutrizione; i progressi nel campo della sanità e dell’istruzione rischiano di essere vanificati.
Donne e bambini sono particolarmente vulnerabili. Le donne soffrono la brutalità delle violenze e degli abusi sessuali, durante e dopo il conflitto. In anni recenti, sono stati documentati degli stupri di massa in Bosnia–Erzegovina, Cambogia, Liberia, Perù, Somalia e Uganda [per non parlare dei conflitti che hanno fatto seguito alla stesura di questo libro: guerre successive all’11 Settembre, Ucraina e Gaza, nde]. Molte di queste donne continuano a soffrire di traumi prolungati, aggravati dall’ostracismo da parte della famiglia e della comunità allargata. È un dato ormai assodato: in molte situazioni di conflitto, la violenza contro le donne è una strategia istituzionalizzata adottata dalle fazioni in guerra, comprese le forze governative.
Gli abitanti dei paesi ricchi sono legati a filo doppio con le comunità dei paesi poveri, dove le vite sono devastate dal conflitto. Il traffico internazionale di droga e il mercato illegale delle armi forniscono il supporto finanziario e le armi da cui questi violenti conflitti sono alimentati.
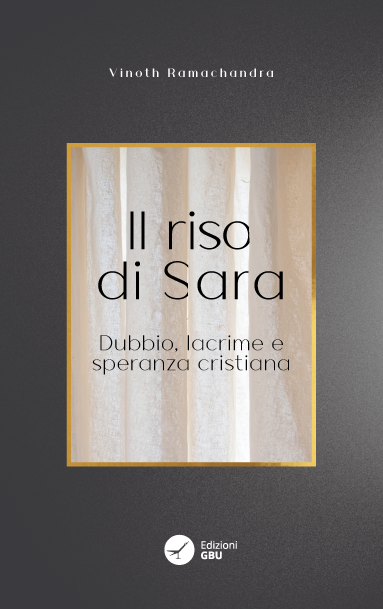 I maggiori commercianti di armi al mondo sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e alcuni altri governi dell’Europa occidentale; i paesi cui costoro vendono costosa tecnologia militare, spesso, non sono certo dei modelli di democrazia e rispetto dei diritti umani. L’arrivo di rifugiati e richiedenti asilo sulla soglia dei paesi ricchi alimenta il diffondersi del razzismo e della xenofobia in tali paesi e porta a una frattura nelle relazioni comunitarie. Le illecite fortune di quanti traggono enormi profitti dalla guerra e dai conflitti locali sono spesso immagazzinate nel sistema bancario internazionale posseduto e controllato dalle nazioni ricche del mondo o in paradisi fiscali che sono protettorati degli Stati Uniti e del Regno Unito.
I maggiori commercianti di armi al mondo sono gli Stati Uniti, il Regno Unito e alcuni altri governi dell’Europa occidentale; i paesi cui costoro vendono costosa tecnologia militare, spesso, non sono certo dei modelli di democrazia e rispetto dei diritti umani. L’arrivo di rifugiati e richiedenti asilo sulla soglia dei paesi ricchi alimenta il diffondersi del razzismo e della xenofobia in tali paesi e porta a una frattura nelle relazioni comunitarie. Le illecite fortune di quanti traggono enormi profitti dalla guerra e dai conflitti locali sono spesso immagazzinate nel sistema bancario internazionale posseduto e controllato dalle nazioni ricche del mondo o in paradisi fiscali che sono protettorati degli Stati Uniti e del Regno Unito.
Sul piano personale, mia moglie Karin è morta sei mesi prima della mia visita alla mostra di Londra sull’influenza del 1918–1919. Nel suo ultimo sermone nella nostra chiesa, subito prima del Natale del 2017, ha inquadrato i disturbi dovuti al cancro da cui era affetta e la sua imminente morte nella prospettiva storica del cantico di Maria, il Magnificat: un giorno il Salvatore rimetterà a posto il mondo ma nel frattempo noi dobbiamo convivere con tanti quesiti irrisolti. Maria ha accettato il biasimo sociale derivante dal fatto di essere rimasta incinta senza essere ancora sposata e anche la prospettiva di perdere il figlio, destinato a morire giovane. All’inatteso sopraggiungere di un’afflizione, quasi tutti ci chiediamo:
«Perché a me?». Come sottolineato da Karin, però, dovremmo piuttosto chiederci: «Perché non a me?». Dopo tutto, viviamo in un mondo messo sottosopra, dove uomini, donne e bambini muoiono di continuo per incidenti, violenze, malattie, fame o a causa di qualche disastro naturale. Cristo non ci ha mai promesso di esserne immuni. Come cristiani, siamo parte di un’umanità sofferente, ancora in attesa di redenzione.
Le domande sulla sofferenza, però, possono essere assillanti e spesso possono arrivare a paralizzarci. La sofferenza, poi, non deriva solo dalla perdita di una persona cara ma dalla perdita della salute, del lavoro e della reputazione; dall’infertilità e dalla disabilità; inoltre, dalla spiacevole presa di coscienza dell’impunità spesso goduta dall’ingiustizia e dall’empietà. Nella Seconda Lettera di Pietro, leggiamo di Lot, nipote di Abramo, abitante delle antiche città di Sodoma e Gomorra, «rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati (quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua animagiusta a motivo delle loro opere inique)» (2 Pt 2:7–8).
Tutta la Bibbia è percorsa da una lunga, ricca e spesso ignorata tradizione di lamenti. Incomincia con le sconcertanti parole attribuite a Dio stesso nei primi capitoli della Genesi: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo» (Gen 6:5–6). Culmina nel grido dei martiri intorno al trono di Dio nella visione del veggente Giovanni: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» (Ap 6:10)
L’articolo Perché, Signore, nascondi il tuo volto? proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/perche-signore-nascondi-il-tuo-volto/

