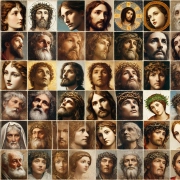Di Francesco Schiano Lomoriello, Staff GBU Napoli.
L’espressione “ricerca del Gesù storico” fa riferimento allo sforzo di ricostruire un ritratto di Gesù di Nazareth che scavalchi quello offerto dai vangeli, per giungere più vicino possibile alla verità storica.
L’assunto di partenza è che gli autori dei Vangeli non siano stati motivati dal desiderio di riportare la verità oggettiva, ma da intenti teologici e dottrinali. Pertanto, li si accusa di avere inserito nei loro racconti fatti non accaduti realmente, o almeno non nelle modalità descritte, per sostenere le posizioni delle comunità cristiane di cui erano espressione.
Tre fasi della ricerca
Oggi si riconoscono tre fasi della ricerca:
– La prima si è sviluppata tra il XVIII e la prima parte del XX secolo. Il Razionalismo di derivazione illuiminista spinse studiosi come Hermann Reimarus a suggerire la differenza tra il “Cristo della Fede” e il “Gesù della Storia”. Vennero scritte biografie di Gesù che erano soprattutto il tentativo di razionalizzare e naturalizzare i vangeli, epurandoli di tutti gli elementi sovrannaturali. Rudolf Bultmann è stato l’ultimo protagonista di questa fase e colui che vi ha posto fine. Egli suggeriva che il Gesù della Storia fosse inaccessibile alla ricerca. Tale conclusione era stata motivata dalla constatazione che ogni biografia di Gesù pubblicata nei precedenti 2 secoli aveva offerto un ritratto diverso dalle altre, alimentato non tanto dagli auspicati criteri di oggettività, quanto dall’orientamento e dai pregiudizi di chi l’aveva proposto.
– Proprio un discepolo di Bultmann, Ernst Kasemann, è stato l’iniziatore della seconda ondata di studi sul Gesù storico. Convinto, a differenza del suo maestro, della possibilità di colmare il gap tra il Cristo della Fede e il Gesù della Storia attraverso lo studio critico dei testi del Nuovo Testamento. Era la metà del XX secolo e questa stagione durò poco perché importanti scoperte archeologiche imposero un nuovo approccio alla ricerca.
– Studi basati su scoperte come la biblioteca di Nag Hammadi e i rotoli di Qumran permisero agli storici di giungere a una conoscenza più profonda della società e della cultura del Medio Oriente antico. Tale conoscenza è il fondamento dell’approccio della terza fase della ricerca sul Gesù storico. A partire dagli anni ‘60 del secolo scorso, sempre più studiosi si sono interessanti alla possibilità di distillare la verità storica dai testi del Nuovo Testamento. Questo non solo attraverso un lavoro filologico e letterario, ma attraverso l’analisi dei resoconti biblici alla luce delle conoscenze acquisite sulla società nella quale Gesù visse e i vangeli furono scritti. Una caratteristica importante di questa terza fase è la presenza tra i suoi animatori di studiosi atei e agnostici, che in alcuni casi sono cristiani deconvertiti.
Come affrontare la questione
Confrontarsi con le opere di studiosi, passati e presenti, che mettono fortemente in discussione l’affidabilità dei racconti evangelici può rappresentare una sfida di non poco conto per i credenti. Tuttavia abbiamo gli strumenti per affrontare tale sfida e trasformarla in un’opportunità evangelistica.
1. I testimoni oculari e il vero Gesù
L’assunto di partenza a cui abbiamo fatto riferimento, cioè la convinzione che i Vangeli canonici non rappresentino resoconti storici ma ricostruzioni teologiche della figura di Gesù, non è assolutamente dimostrato. Le prove interne sembrano suggerire tutt’altro. Se si pensa alla presenza di tanti particolari non necessari alla narrazione (il numero di pesci pescato alla seconda pesca miracolosa, il giovane coperto da un lenzuolo presente all’aresto di Gesù, il fatto che Giovanni arrivò al sepolcro prima di Pietro, ecc.), alle storie che mettono in cattiva luce i discepoli, o alla dichirazione d’intenti che Luca offre all’inizio del suo Vangelo (…è parso bene anche a me, dopo essermi accuratamente informato di ogni cosa dall’origine, di scrivertene per ordine…), si può sostenere ragionevolmente che gli evangelisti abbiano riportato testimonianze oculari con lo scopo di presentarci il vero Gesù.
Proprio la categoria della testimonianza è quella che suggerisce lo studioso Richard Bauckham nel suo Gesù e i testimoni oculari1 per comprendere correttamente il genere letterario Vangeli. Estremamente soggettivo, ma non per questo non attendibile.
D’altra parte, la data di pubblicazione degli scritti del Nuovo Testamento, collocabile al più tardi tra il 60 e il 95 d.C., rende piuttosto difficile sostenere che essi contengano miti e leggende, visto che i testimoni oculari dei fatti narrati erano ancora in circolazione in quegli anni.
2. Incontrare il Cristo con la ricerca del Gesù storico
Oggi la maggior parte degli studenti è convinta che la Bibbia non sia un testo affidabile; parlare di Gesù a partire da ciò che affermano i Vangeli spesso vuol dire scontrarsi con questo pregiudizio. In un contesto simile, la ricerca del Gesù storico rappresenta un punto di incontro tra il credente e lo scettico. In altre parole, ci si può avvicinare ai testi del Nuovo Testamento da scettici e analizzarli con gli strumenti della storiografia moderna. Si può cercare di capire chi sia stato Gesù di Nazareth, senza dover prima accettare la dottrina dell’ispirazione della Bibbia, e incontrare il Cristo.
Non mancano le testimonianze di persone comuni e studiosi2 che, analizzando i Vangeli da non credenti, sono finite per riconoscere Gesù come loro Dio e Signore, proprio come accadde al primo scettico, il discepolo Tommaso.