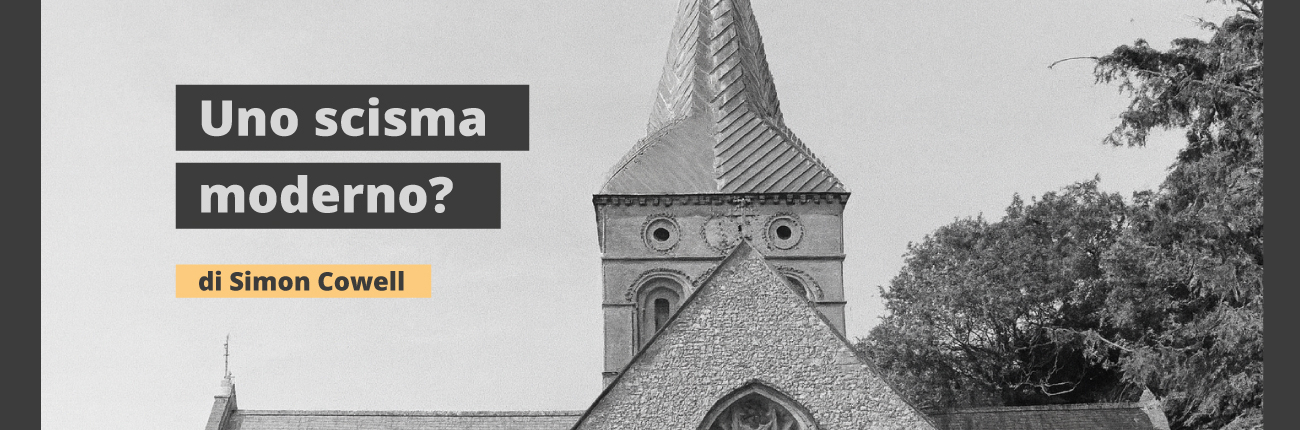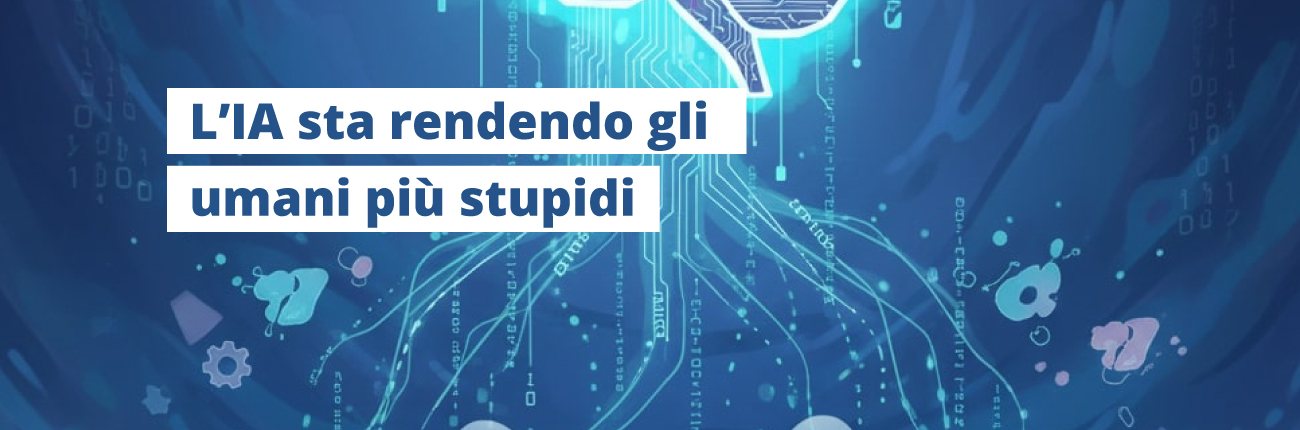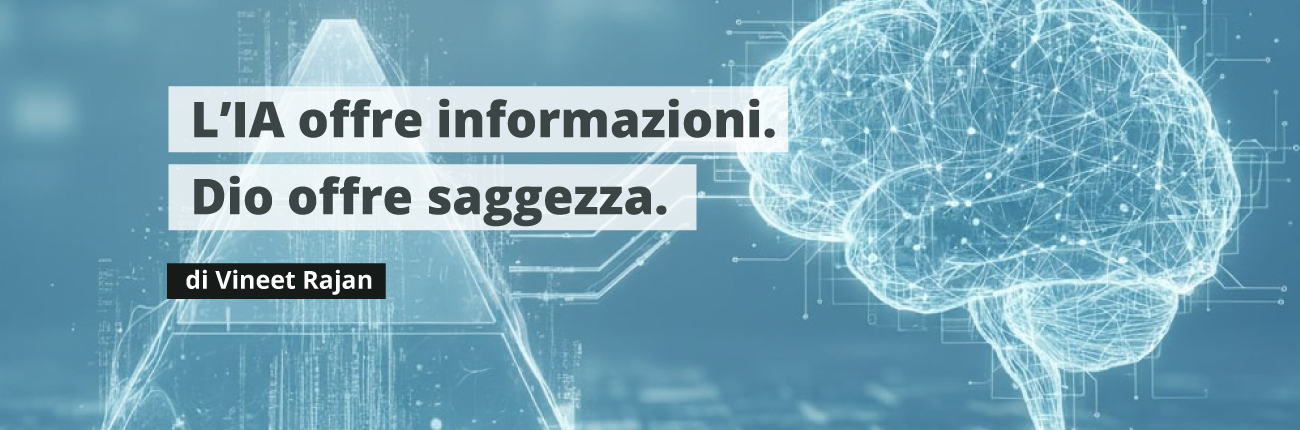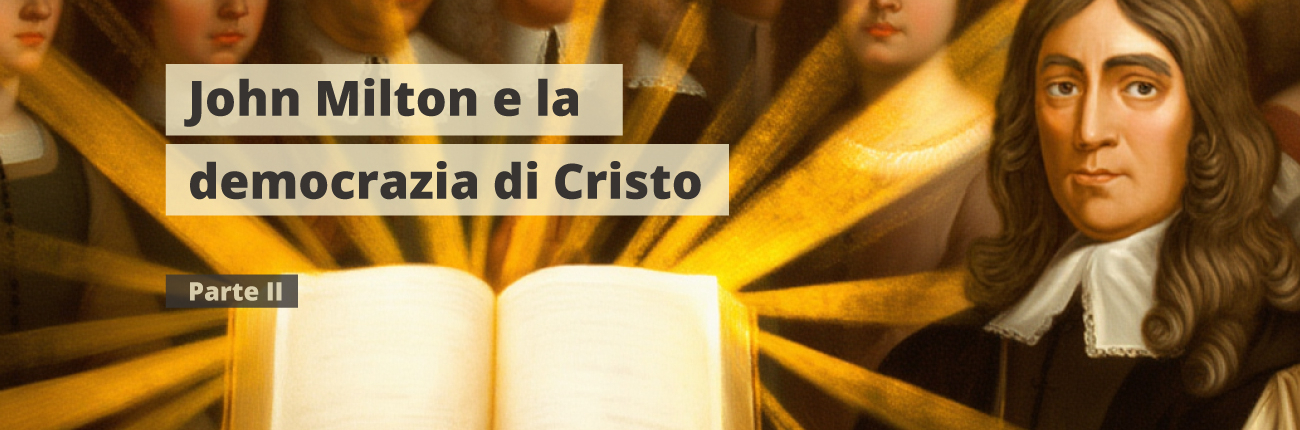
Una forma di tirannia esterna si era presentata una volta di più nei primi anni delle guerre civili inglesi (1642-46 / 1648-49) nella veste di censura e limitazioni alla libertà di parola e stampa. La libertà di coscienza e di parola non deriva dall’idea che la verità non esista, ma che sia soltanto un costrutto soggettivo. Per Milton la verità esiste eccome, ma è soltanto nella libertà che l’uomo può conoscerla, o meglio, soltanto nella libertà l’uomo può essere da essa conosciuto.
Il portato delle argomentazioni di John Milton nell’Areopagitica depone contro la dogmatizzazione della verità e la censura della falsità. Se la libertà cristiana ha reso il cristiano libero di discernere la verità e sceglierla tra le false alternative, il confronto con queste ultime che la libertà cristiana consente e cui invita favorisce la manifestazione di una virtù autentica e la fortificazione interiore del cristiano nella scelta della verità. Non solo ma, come John Goodwin stesso sostiene,1 il libero confronto tra le verità contribuisce a una comprensione sempre più piena e reale della verità.2
Roger Williams a sua volta sostiene che l’atteggiamento di coloro che nelle due camere altro non accettano che sentire ciò che loro aggrada rende “raramente possibile che qualunque altra Luce […] risplenda sulle Anime di voi Onorevoli, quantunque mai tanto soave, tanto necessaria, e benché venga da Dio, dal Cielo”.3 La paura, la coercizione e la mancanza di conoscenza e confronto non fanno che pervertire, soffocare o intorpidire la verità. La libertà rinvigorisce la ragione e le consente di far affiorare la verità. Una volta di più, la qualità paradigmatica del pensiero di Dietrich Bonhoeffer si dimostra pregnante nelle parole: “La verità nasce unicamente dalla libertà”.4
In definitiva, la lezione della libertà cristiana in Areopagitica è che “la verità non è proprietà di alcuna forma esterna, neppure di una forma che proclami quella stessa verità”.5 La verità non ha bisogno dell’aiuto dell’uomo per essere preservata o prevalere, né può essere posseduta, manipolata o controllata da agenti esterni. Piuttosto, l’uomo ha bisogno che la verità possieda e controlli il suo essere interiore. Non sorprende che in questa “età del vangelo” Cristo, la verità, sia “il solo Signore della Coscienza”6 e sia consentito alla zizzania di crescere accanto al grano.7 Su questa falsariga, The Standard Confession of General Baptists (1660) afferma:
[…] è la volontà e la mente di Dio (in questa età del vangelo) che tutti gli uomini godano della piena libertà di Coscienza in materia di Religione o Culto, senza che debbano incorrere nella minima forma di oppressione o persecuzione, semplicemente in ragione del vangelo; che una qualsivoglia Autorità agisca diversamente crediamo con piena fiducia sia espressamente contrario alla mente di Cristo, che vuole […] che le Zizzanie e il Grano crescano insieme nel campo (che è il mondo) fino alla mietitura (che è la fine del mondo) […]8
L’adesione di Milton a queste posizioni è estranea all’impulso di auto-preservazione che muoveva i Battisti Generali. Cionondimeno, un principio comune anima l’uno e gli altri. Mentre vivono tra il “già” e il “non ancora”, entrambi considerano la libertà cristiana come fondamento ultimo della tolleranza in materia di fede e coscienza, poiché il vangelo libera la verità dalle camicie di forza della colpa, del dubbio, della paura, delle narrazioni umane e delle imposizioni legali per consegnarla alla conoscenza di Dio in Cristo per mezzo dello Spirito della verità.
Il Paradiso Perduto era già in cantiere quando un rinnovato senso di urgenza profetica invitò il poeta a mettere da parte, un’ultima volta, la sua vocazione poetica per scrivere A Treatise of Civil Power (1659) e Considerations Touching the Likeliest Means to Remove Hirelings out of the Church (1659). Una volta di più, nel rivolgersi al “Parlamento del Commonwealth di Inghilterra con i relativi Domini”, Milton parlava come cristiano a cristiani. Qui, più che mai prima, il polemista appare, nelle parole di John Coffey, tra le fila di “quel numero sostanziale di Battisti, Indipendenti radicali e Levellers” che “insistevano che il paradigma del Nuovo Testamento prevedeva che la chiesa fosse una comunità non coercitiva e puramente volontaria nel mezzo di una società pluralista governata da uno stato ‘meramente civile’. Sebbene non priva di ambiguità, la loro posizione costituiva un sorprendente punto di discontinuità dagli assunti costantiniani della Riforma magisteriale”.9
Nel 1659 Milton condivideva ormai con Williams la distinzione tra la comunità religiosa volontaria e lo stato civile identificata in queste parole. Mentre, tuttavia, Williams considerava la fonte dello stato civile “non religiosa, cristiana ecc., ma naturale, umana e civile”,10 Milton lo fa risalire allo stesso paradigma neo-testamentario che in Cristo si sviluppa secondo le direttrici di una comunità religiosa non coercitiva e puramente volontaria e uno stato meramente civile. La chiesa e lo stato civile, in altre parole, erano declinazioni della medesima realtà, l’unica, il “già” e il “non ancora” di Dio in Cristo.
Nei trattati menzionati sopra, Milton mostra altresì una peculiare attenzione alle preoccupazioni quacchere del tempo. Le sue argomentazioni, diversamente da quelle quacchere, però, non si incardinano sulla nozione di intrinseca illegittimità di ogni autorità terrena, ma sull’illegittimità della fusione di autorità religiosa e civile nel pronunciarsi contro la coscienza individuale. Se Considerations Touching the Likeliest Means faceva sue le conclusioni quacchere sulla corruzione della chiesa e l’illegittimità delle decime, A Treatise of Civil Power levigava le argomentazioni di Areopagitica per tracciare, con Williams, un confine netto tra questioni civili e questioni di coscienza. Nel distinguere tra le due, Milton giungeva a concepire l’eresia come punibile da parte dell’autorità civile unicamente nella misura in cui rappresentasse una breccia visibile della legge civile.11 La fede personale, così come il divorzio e la parola ricadevano sotto la giurisdizione della coscienza, poiché “per la fede o per la pratica religiosa secondo la persuasione che poggia sulla coscienza nessun uomo dovrebbe essere punito né molestato da qualsivoglia agente esterno sulla terra”.12
Se nei trattati politici Milton aveva rivolto il suo sguardo alla libertà cristiana intesa come libertà da governi illeciti e oppressivi, sentiva ora di dover assolvere il proprio dovere davanti a Dio difendendo la libertà cristiana intesa come emancipazione dal dominio degli uomini in questioni di coscienza.13 Tuttavia, pur estendendo la libertà di coscienza allo stesso modo a tutti quei Protestanti che, pur nella loro eterogeneità, si fondavano sulle Scritture e agli Ebrei, Milton, diversamente da Williams, esclude il Cattolicesimo dalla portata della tolleranza dal momento che esso non è una religione della coscienza, ma un “principato romano […] che cerca di tener vivo il suo antico dominio universale sotto un nuovo nome”.14
Un rifiuto del supersessionismo agostiniano sembra soggiacere al pensiero di Milton. Secondo il magistero alto della Chiesa inglese, come della Riforma magisteriale tutta, la chiesa aveva preso il posto di Israele come regno di Dio sulla terra, un regno spirituale e temporale a un tempo preposto a esercitare, per diritto divino, controllo su tutte le strutture sociali e politiche, come su quelle religiose. Se la Chiesa di Inghilterra e l’establishment puritano sostenevano rispettivamente che l’autorità politica e civile riposava nelle mani del re e del parlamento, affermavano all’unisono che la legge morale di Dio dovesse essere imposta nella sua interezza sia dal potere religioso sia da quello civile. Questo non valeva solo per quella che per i Calvinisti era la seconda tavola del Decalogo, ovvero i comandamenti legati ai rapporti sociali, ma anche a quei comandamenti che riguardavano il rapporto dell’uomo con Dio, la prima tavola.
Milton afferma che uno stesso spirito ‘papale’ accomuna la chiesa ufficiale e i puritani oltranzisti alla chiesa romana. Per Milton, né la chiesa né lo stato debbono in nessun caso esercitare dominio sulla coscienza individuale. Piuttosto, l’una e l’altro dovrebbero essere estensione di una coscienza libera. Sulla stessa falsariga, nel rivendicare la libertà della coscienza da restrizioni esterne e interiori, i termini della libertà cristiana prevedono un porto interiore sicuro di libertà – il proprio stato e la propria chiesa – che deve estrinsecarsi in forma civile e religiosa. Le risultanti istituzioni religiose e civili devono necessariamente astenersi dall’autoaffermazione, dall’auto-preservazione come pure dall’imposizione delle loro aspirazioni, dal momento che la loro stessa esistenza dipende indivisibilmente da ed è vincolata alla libertà individuale. I benefici liberali di questa prospettiva investiranno naturalmente il cristiano come il non cristiano in una società che comprende elementi cristiani come elementi secolari sotto il governo di Cristo e della libertà cristiana in uno stato civile al servizio di leggi liberali e democratiche.
Milton “si prodigò per cambiare il mondo come […] lui stesso “era stato cambiato”.15 Nella lotta libertaria per affermare i principi della libertà cristiana in Inghilterra durante gli anni dell’Interregno, egli si trovò nondimeno di fronte alla tragica realtà del progressivo disfacimento della libertà che culminò nella Restaurazione. Per recuperare un’espressione utilizzata da Steven Marx, Milton era nel 1660 un profeta disarmato.16 Le armi della legge e della guerra avevano fallito nel restituire il “già” della realtà di Dio in Cristo. La conversione, e non più le riforme sociali, divenne ora il centro della sua testimonianza. Se il rinnovamento esterno poteva unicamente iniziare con il rinnovamento interiore di Adamo ed Eva, il solo riscatto della libertà interiore avrebbe restituito l’amore come matrice di ogni libertà esterna.
NOTE
1Vd. D. Loewenstein, “Toleration and the Specter of Heresy in Milton’s England”, in Milton and Toleration, a cura di S. Achinstein e E. Sauer, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 45-71. Il ritratto che Loewenstein fornisce di Goodwin è quello di una personalità speculativa. Aperto oppositore del diritto divino dei re (vd. Os Ossorianum, or a Bone for a Bishop, 1643, contro Griffith Williams, vescovo di Ossory) e sostenitore del regicidio (The Obstructors of Justice, 1649), dal 1642 al 1646 Goodwin si dedicò principalmente a combattere intendimenti e apologie della verità dogmatici ed esclusivisti e i sistemi autoritari che li imponevano.
2Vd. M.F. Norton, “The Praxis of Milton’s Truth: Proairesis and Qualifications in the Civil Liberty Tracts”, Milton Quarterly 28: (1994) pp. 47-56. Cfr. John Milton, Complete Prose Works, vol. 6, a cura di M. Kelley, New Haven, CT, Yale University Press, 1953, pp. 122-3.
3Queries of the Highest Consideration, in The Complete Writings of Roger Williams, vol. 1, New York, Russell and Russell, 1963.
4Così in Nachfolge. Cit. in E. Metaxas, Bonhoeffer, Nashville, Nelson, p. 95
5S. Fish, “Driving from the Letter”, in M. Nyquist e M.W. Ferguson, a cura di, Re-membering Milton: Essays on the Texts and Traditions, New York, Methuen, 1987, p. 243.
6W.L. Lumpkin, a cura di, Baptist Confessions of Faith, art. 46, Chicago, Judson Press, pp. 331-32.
7Cfr. Areopagitica con Mt 13:24-30.
8W.L. Lumpkin, a cura di, Baptist Confessions of Faith, art. 24, pp. 232-33.
9J. Coffey, “Puritanism and Liberty Revisited: The Case for Toleration in the English Revolution”, The Historical Journal 41: (1998), pp. 961-85.
10R. Williams, La sanguinaria dottrina della persecuzione per causa di coscienza (1644), a cura di M. Rubboli, Chieti, GBU Edizioni, 2018, p. 398.
11John Milton, Complete Prose Works, vol. 7, p. 252.
12Ivi, p. 242.
13Ivi, p. 240.
14John Milton, Complete Prose Works, vol. 7, p. 255.
15Queste parole sono riferite da Barbour ai primi Quaccheri. Vd. H. Barbour, The Quakers in Puritan England, New Haven, CT, Yale University Press, 1964, p. 160.
16S. Marx, “The Prophet Disarmed: Milton and the Quakers”, Studies in English Literature 32: (1992), pp. 111-28.
Traduzione con il permesso di Wipf & Stock Publishers, www.wipfandstock.com
Filippo Falcone
L’articolo John Milton e la democrazia di Cristo (II) proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/john-milton-e-la-democrazia-di-cristo-ii/

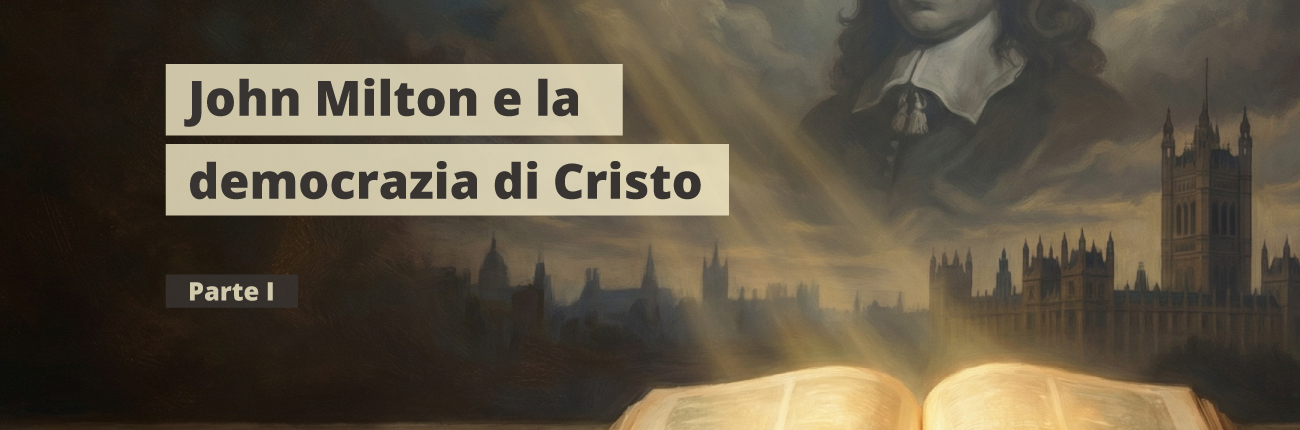
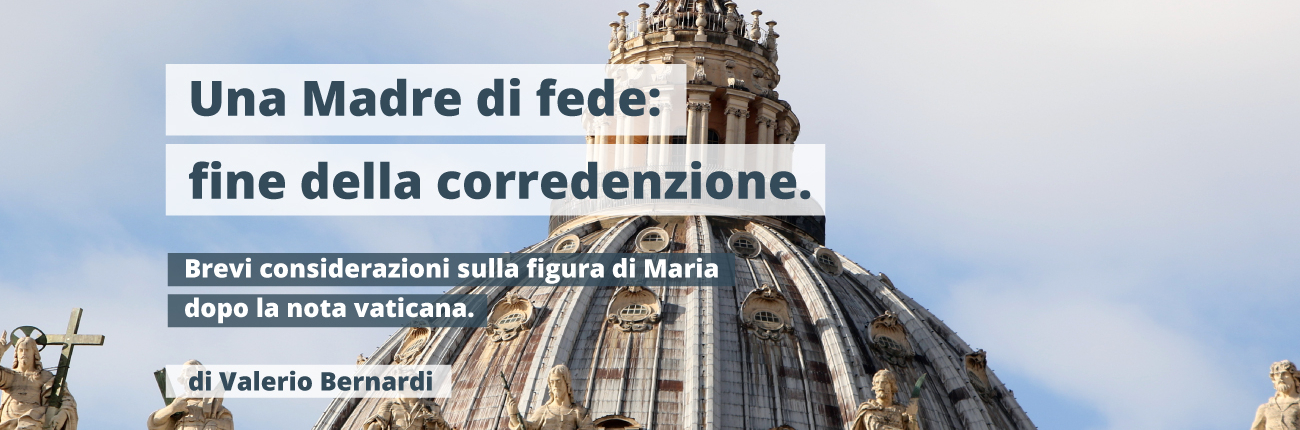
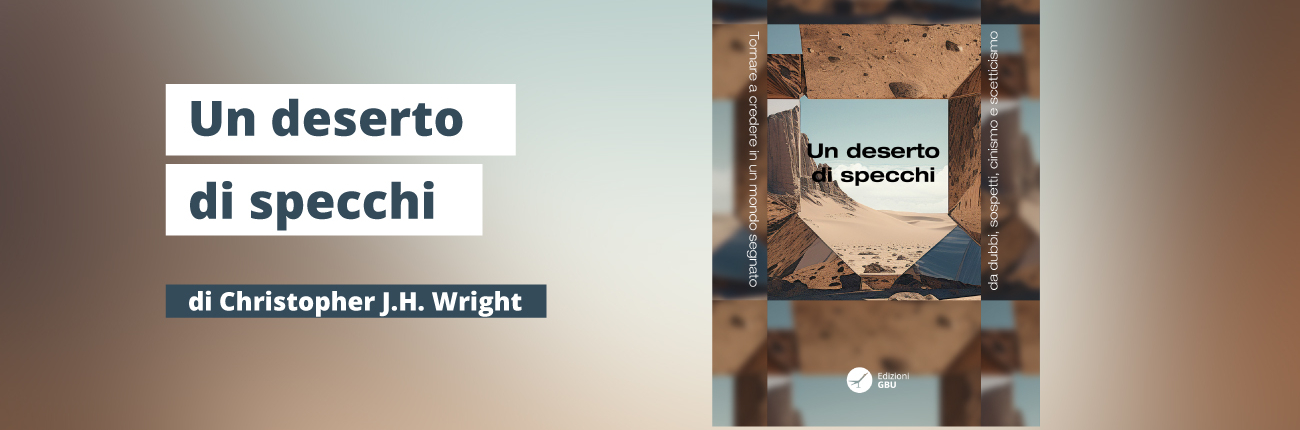
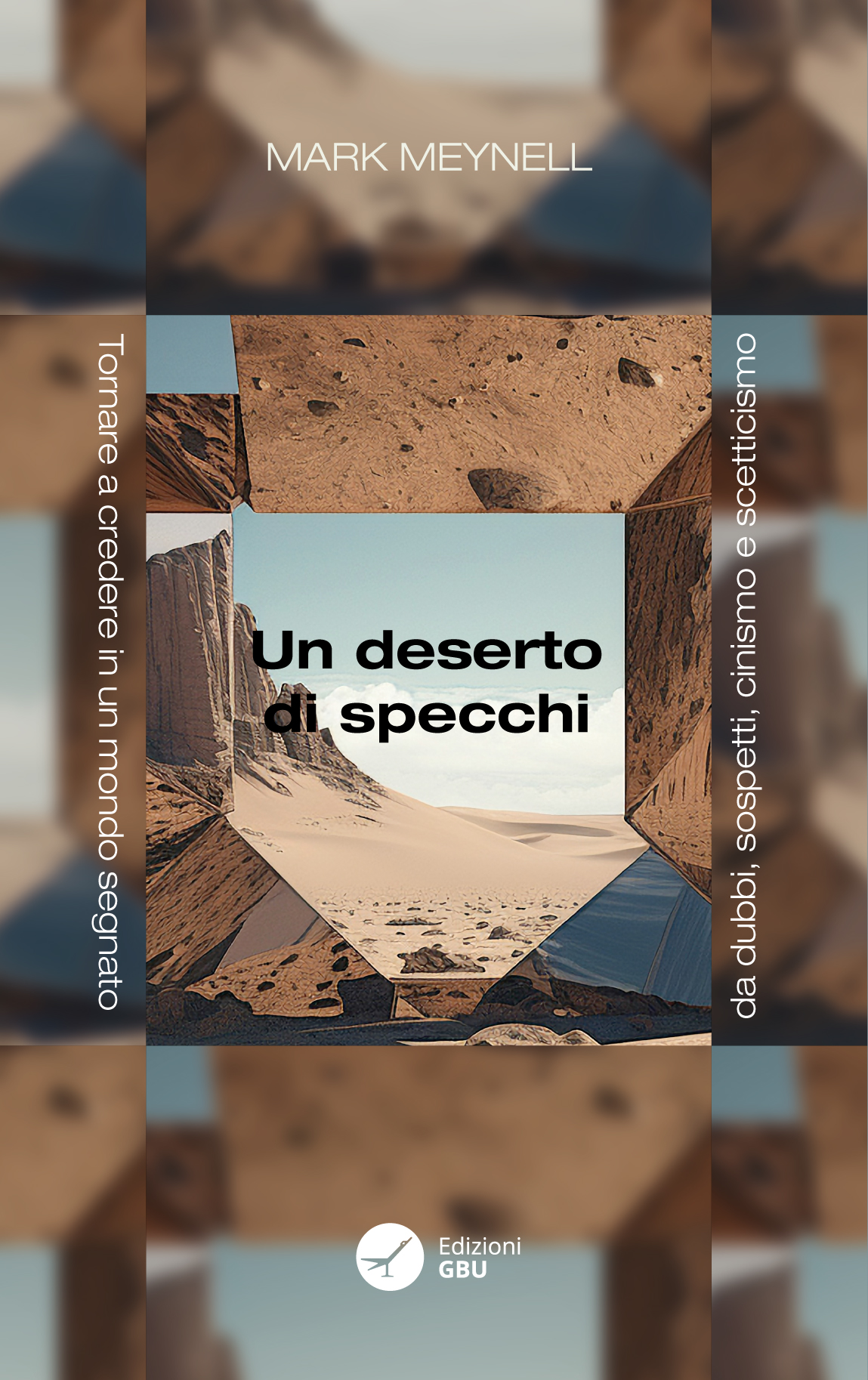 so, a ignoranza o a qualcuna delle miriadi di diagnosi e medicine inadeguate di cui l’umanità è stata prodiga, bensì a una ribellione morale di fondo contro la fonte stessa della nostra umanità e al nostro rifiuto della benevola autorità di Dio nel suo mondo. Questa è la radicale analisi biblica del peccato. Qualsiasi cosa di inferiore è superficiale e non è in grado di dare senso alla realtà così come la conosciamo. Per me ha senso che il Dio creatore di un tale, splendido mondo debba, per amore, scegliere di non distruggerlo ma di redimerlo per mezzo di Gesù di Nazaret e della sua incarnazione, della sua morte, risurrezione e ascensione. Ha senso, infine, che dopo avere promesso e realizzato tutto questo che troviamo nella storia biblica Dio non lasci incompiuto il progetto (non lo farà); farà invece terminare la storia con la piena restaurazione del creatopreconizzata da Isaia, da Paolo e da Giovanni di Patmos. È questa storia ad avere senso, in quanto è la storia evangelica della missione di Dio, che guida la nostra missione nel mondo. È questa la storia, questa la persona di cui possiamo fidarci, in un mondo in cui la fiducia è soverchiata dal cinismo, dagli abusi, dall’ironia e dalle teorie cospirazioniste. La critica straordinariamente sensibile e documentata mossa da Mark Meynell alla nostra cultura mette in luce come la perdita di fiducia a ogni livello della società rifletta la perdita di qualsiasi capacità di «dare un senso» alla «vita, all’universo e a tutto quanto»; il che è, a sua volta, il prodotto del rifiuto deliberato di qualsiasi narrazione capace di garantire un tale “senso” universale, all’indomani dell’evidente fallimento della “narrazione” della modernità. Evidentemente, possiamo fidarci soltanto se siamo convinti dell’affidabilità sia della storia offerta sia di colui che ci invita a prendervi parte e della capacità, in qualche modo, di garantire un lieto fine. La terza parte del presente volume presenta in modo convincente la tesi secondo cui la narrazione evangelica di tutta la Bibbia offre proprio una tale sicurezza, una sofferta parola di speranza in un «deserto di specchi», un invito a tornare a credere e una base motivazionale per una missione biblicamente radicata, autentica e umile, nelle sue sicurezze, per il popolo di Dio nel mondo di Dio.
so, a ignoranza o a qualcuna delle miriadi di diagnosi e medicine inadeguate di cui l’umanità è stata prodiga, bensì a una ribellione morale di fondo contro la fonte stessa della nostra umanità e al nostro rifiuto della benevola autorità di Dio nel suo mondo. Questa è la radicale analisi biblica del peccato. Qualsiasi cosa di inferiore è superficiale e non è in grado di dare senso alla realtà così come la conosciamo. Per me ha senso che il Dio creatore di un tale, splendido mondo debba, per amore, scegliere di non distruggerlo ma di redimerlo per mezzo di Gesù di Nazaret e della sua incarnazione, della sua morte, risurrezione e ascensione. Ha senso, infine, che dopo avere promesso e realizzato tutto questo che troviamo nella storia biblica Dio non lasci incompiuto il progetto (non lo farà); farà invece terminare la storia con la piena restaurazione del creatopreconizzata da Isaia, da Paolo e da Giovanni di Patmos. È questa storia ad avere senso, in quanto è la storia evangelica della missione di Dio, che guida la nostra missione nel mondo. È questa la storia, questa la persona di cui possiamo fidarci, in un mondo in cui la fiducia è soverchiata dal cinismo, dagli abusi, dall’ironia e dalle teorie cospirazioniste. La critica straordinariamente sensibile e documentata mossa da Mark Meynell alla nostra cultura mette in luce come la perdita di fiducia a ogni livello della società rifletta la perdita di qualsiasi capacità di «dare un senso» alla «vita, all’universo e a tutto quanto»; il che è, a sua volta, il prodotto del rifiuto deliberato di qualsiasi narrazione capace di garantire un tale “senso” universale, all’indomani dell’evidente fallimento della “narrazione” della modernità. Evidentemente, possiamo fidarci soltanto se siamo convinti dell’affidabilità sia della storia offerta sia di colui che ci invita a prendervi parte e della capacità, in qualche modo, di garantire un lieto fine. La terza parte del presente volume presenta in modo convincente la tesi secondo cui la narrazione evangelica di tutta la Bibbia offre proprio una tale sicurezza, una sofferta parola di speranza in un «deserto di specchi», un invito a tornare a credere e una base motivazionale per una missione biblicamente radicata, autentica e umile, nelle sue sicurezze, per il popolo di Dio nel mondo di Dio.