Tempo di lettura: 4 minutiCon l’articolo di oggi (lunedì 27 ottobre 2025) iniziamo la pubblicazione di un piccolo dossier sull’intelligenza artificiale, pubblicato nel numero Luglio/Agosto della rivista Christianity today.
Gli articoli sono tradotti e pubblicati con il permesso di Christianity Today.
Cos’è l’intelligenza (artificiale)?
Quattro esperti si confrontano sulla conoscenza nell’era dell’IA.
Storicamente, i teologi hanno individuato diverse caratteristiche di ciò che significa essere creati a immagine di Dio: la razionalità, la capacità di amare e la giustizia umana prima della Caduta.
“Nella storia dell’interpretazione è stato fin troppo facile piegare questo termine estremamente aperto, ‘immagine di Dio’, al servizio del pensiero filosofico e religioso contemporaneo”, osserva lo studioso biblico David J. A. Clines.
Oggi torniamo a confrontarci con questo termine di fronte a un panorama tecnologico di robot quasi autonomi e grandi modelli linguistici (LLM). In molti sensi, ci stiamo chiedendo che cosa significhi essere umani. Soprattutto ora che l’intelligenza artificiale generativa avanza, potremmo iniziare a mettere in discussione il nostro posto nel mondo. Possiamo intrattenere relazioni interpersonali con ChatGPT? Se perdiamo il lavoro o il nostro mestiere a favore dell’intelligenza artificiale, scendiamo di rango nella catena sociale?
Le nostre domande non riguardano solo il lavoro, ma anche teologia ed etica. Come cristiani dobbiamo chiederci quale ruolo abbia l’intelligenza nell’imago Dei e se l’IA sia davvero intelligente. Non siamo né Dio, né animali, né macchine. Buona parte del mondo è strutturata per farci vivere in modo meno umano: come immaginare di riflettere Dio in un mondo sempre più tecnologico?
Per l’edizione cartacea di luglio/agosto, CT ha invitato un ingegnere software, un ricercatore, un imprenditore tech e un professore a riflettere su come definiamo l’intelligenza, sia nei calcoli matematici, sia nella nostra capacità di amare o di conoscere per esperienza.
Siamo umani, dopotutto.
(Kara Bettis Carvalho, editor della rubrica Ideas di Christianity Today).
1° Articolo
La nostra ossessione per le capacità dell’IA non comprende ciò che l’intelligenza è davvero.
(Chris Krycho)
Gran parte del dibattito contemporaneo sugli strumenti di intelligenza artificiale come i large language model (LLM) si concentra, in primo luogo, sul chiedersi se tali strumenti siano veramente intelligenti e, in secondo luogo, su cosa significhi tutto ciò per noi esseri umani, per il nostro lavoro, per l’arte e persino per le nostre relazioni. Per i cristiani, questi problemi sono spesso seguiti da domande o affermazioni sull’IA e l’imago Dei. Si tratta di interrogativi legittimi.
Io sostengo, però, che queste siano per lo più le domande sbagliate. Partono da presupposti errati su cosa sia l’intelligenza. Di conseguenza, portano con sé nozioni fuorvianti su cosa significherebbe per tecnologie come gli LLM essere veramente intelligenti.
Peggio ancora, queste domande non comprendono appieno il rapporto tra intelligenza e natura umana. L’intelligenza non è affatto una cosa unica. I test del QI ci ingannano perché suggeriscono che l’intelligenza sia misurabile e che un singolo numero rappresenti in modo significativo l’intelligenza.
Quei test catturano qualcosa di reale. Predicono con precisione, ad esempio, come le persone si comporteranno all’università e sono in generale indicativi delle probabilità di successo in un’economia basata sulla conoscenza.
Ma c’è molto che non catturano. Per capire cosa intendiamo, consideriamo questa domanda: gli elefanti sono più intelligenti dei delfini? Dipende dal tipo di azione che chiediamo loro di fare. Un elefante non può usare l’eco localizzazione per cacciare e catturare pesci, e un delfino non può usare il naso per cogliere frutti da un albero. Entrambe queste azioni implicano sicuramente tipi di intelligenza e sensi completamente estranei agli umani.
Allo stesso modo, alcuni sistemi software possono superare gli esseri umani in determinati compiti che consideriamo questioni di intelligenza perché li percepiamo come parte della nostra vita mentale. Queste operazioni includono calcoli matematici o persino giochi sofisticati come gli scacchi.
D’altra parte, il robot più avanzato non può (ancora) battere una persona in una partita di basket uno-contro-uno o arrampicarsi su un albero come uno scoiattolo. L’azione incarnata è ancora ben al di là delle nostre migliori capacità di programmazione, inclusa la famosa destrezza.
Tutto ciò mette in evidenza un modo in cui la visione della cultura occidentale sull’umanità è distorta: abbiamo dato all’intelligenza più importanza di quanto dovessimo. Valorizziamo le persone che creano software, scrivono libri o perseguono “la vita della mente”. Compiangiamo coloro che sono rimasti indietro nella transizione della società verso il lavoro della conoscenza; consideriamo il lavoro fisico umile invece di valorizzare la bontà intrinseca del lavoro corporeo.
Ma anche questo è riduttivo: trattare l’intelligenza come una semplice abilità. Gli esseri viventi, e gli umani in particolare, non sono macchine da compiti. Abbiamo fini più alti. Giocare intorno a un tavolo non «completa un compito». Neppure amare qualcuno lo fa!
Quindi, non possiamo dire cosa l’intelligenza in sé richieda da noi. Non solo l’intelligenza appartiene in misure diverse e con funzioni estremamente variabili a molte specie di creature; è anche il punto di partenza sbagliato per riflettere sugli obblighi etici.
In realtà, usare l’intelligenza altrui come fondamento dei nostri doveri etici è perverso. Implicherebbe che più uno è intelligente, maggiore è l’obbligo,e viceversa. Feti, persone con demenza progressiva o con gravi disabilità mentali richiederebbero meno attenzione di un brillante matematico, scienziato, compositore o poeta.
Il Signore invece ci insegna il contrario: «Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me» (Mt 25: 40). I cristiani apprezzano e valorizzano ogni essere umano, qualunque sia la sua capacità, senza fissarsi sul talento intellettuale.
Potremmo cercare di cavarcela parlando di «capacità» anziché di «abilità». Esiste una tradizione – risalente a [epoca] – che collega l’immagine di Dio alla razionalità, cioè alla facoltà di ragionare e agire, piuttosto che alla sottomissione all’istinto. Tale tradizione distingue tra la capacità naturale propria di una specie e le sue eventuali assenze o distorsioni in singoli individui. Dobbiamo quindi distinguere tra la capacità generale di ragionare propria dell’uomo e la sua attuale abilità individuale
Nella sua forma più semplice, la razionalità è quella capacità di ragionare, e anche quella varia enormemente. Sia un neonato che una persona con demenza avanzata potrebbero non essere in grado di ragionare in questo senso, ma entrambi portano comunque l’immagine di Dio.
A prescindere dalle disabilità, ognuno possiede livelli molto diversi di intelligenza lungo i suoi molteplici assi. Non c’è motivo di ritenere che tali differenze siano frutto della Caduta o che saranno eliminate nella Risurrezione. È evidente se pensiamo a talenti fisici: correre o fare matematica complessa.
L’intelligenza quindi non è la stessa cosa della razionalità, e certamente non è identica all’immagine di Dio. Non dobbiamo confondere l’intelligenza effettiva con il valore della creatura o con l’immagine di Dio.
Quali sono, allora, le domande giuste? Una: che cosa significa essere umani. È un interrogativo antico, ma le nostre nuove circostanze possono aiutarci a porlo con maggiore attenzione. Un’altra: come valutare correttamente gli esseri umani – e forse anche le altre creature – non in base all’intelligenza, bensì alla loro creaturalità. Le risposte potrebbero indurci a rifiutare certe strade o a percorrerle in modo particolare.
Chris Krycho
Chris Krycho è ingegnere informatico e compositore. È membro della Holy Trinity Anglican Church e ha conseguito un M.Div. presso il Southeastern Baptist Theological Seminary.
L’articolo Non confondere l’intelligenza con il valore proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/non-confondere-lintelligenza-con-il-valore/
Una memoria che fa giustizia: i 500 anni di storia dell’Anabattismo
Tratto dal libro:
Cinquecento anni dal movimento anabattista (1525-2025)
Una storia da ricordare, un’eredità da vivere e condividere
Mi chiamo Conrad Grebel e quel che sto per raccontarvi ha cambiato radicalmente la mia vita e la vita di tutti i miei fratelli e le mie sorelle. Era la sera del 21 gennaio del 1525 ed eravamo a casa di Anna Felix a Neustadtgasse, a pochi passi dalla cattedrale di Grossmuenster. Troppo vicina per non sentire sulle nostre spalle il peso enorme di una decisione che, quella sera, stavamo da lì a poco per prendere: celebrare dei battesimi di credenti. Mi alzai in piedi, poggiai la Bibbia sulla sedia accanto, mi schiarii più volte la voce. Erano state giornate movimentate. Avevamo parlato tanto, in alcuni casi avevamo persino gridato per difendere le nostre idee con colui che fino a poco prima era stato il nostro maestro, Zwingli. Ma lui aveva il Consiglio comunale dalla sua parte, entrambi interessati più all’ordine pubblico che alla verità.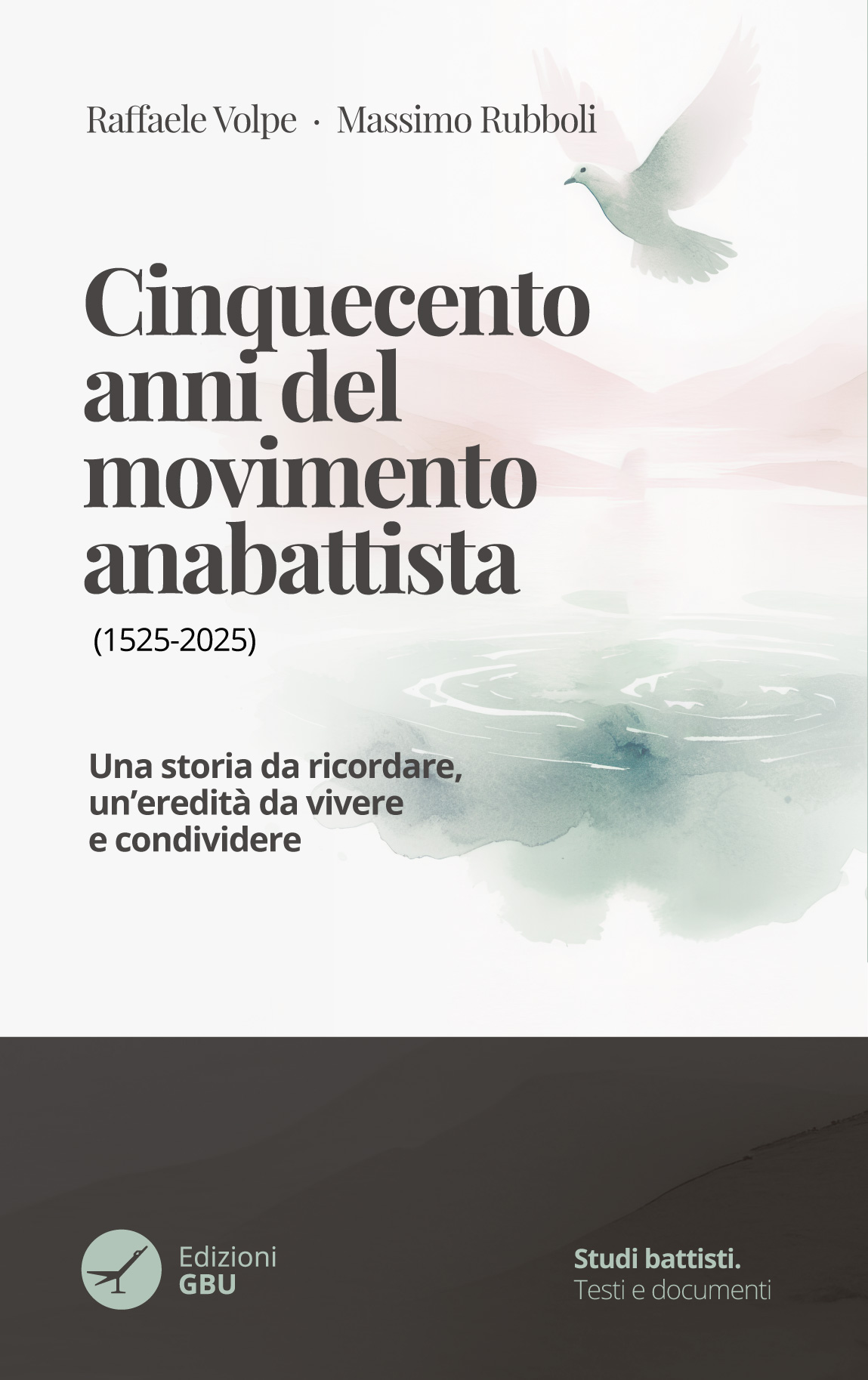 lle nostre mancanze. Aiutaci a esserti fedeli, anche se questa fedeltà ci costerà il prezzo della croce. È nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, che ti prego. Amen». Seguì un lungo silenzio e io tornai a sedermi. L’eco delle ultime parole di Zwingli, dopo la disputa sul battesimo che si era tenuta qualche giorno prima, ancora risuonava nelle mie orecchie: «Che intenzioni avete? Volete dividere la Chiesa?». George Blaurock si alzò. Si aggiustò alla meno peggio nel suo enorme cappotto blu e, con voce sonante – non a caso era chiamato “Giorgio il forte” –, scandendo ad una ad una le sue parole, disse: «Ma quali dubbi? Cosa c’è di più chiaro? Trovatemi un solo passo nella Bibbia in cui il battesimo viene amministrato a un bambino appena nato. Che cosa ci insegnano le parole di Cristo: Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato (Mc 16:16)? Io stasera non torno a casa se prima non sarò stato battezzato».Si sentirono più voci accavallarsi: sì, è vero, ha ragione il fratello George; sì, è proprio così che Cristo dice; ben detto fratello… «Silenzio», dissi, «silenzio», ripetei «dobbiamo esprimerci tutti e soltanto quando tutti avranno preso la parola, decideremo cosa fare». Anna, la più anziana del gruppo, parlò per prima: «Noi non possiamo ignorare il comandamento di Gesù Cristo. Io sono pronta. E sono certa che anche tutti gli altri, come me, lo sono. Vero?». Non aveva ancora pronunciato per intero la parola ‘vero’ che si era girata prima alla sua sinistra e da lì velocemente aveva guardato tutti noi negli occhi fino a fermarsi alla sua destra, lì dove era seduto Johann Broetli.Broetli si sentì interpellato da quello sguardo di Anna e disse la sua. Gli altri lo seguirono. Parlarono tutti e tutti furono concordi. Mi alzai in piedi nuovamente, sentii una misteriosa forza nei muscoli delle mie gambe, chiesi a Felix Mantz di portarmi una brocca d’acqua e un catino. Ci inginocchiammo e pregammo tutti, chiedendo a Dio di aiutarci a compiere il suo volere e ad avere misericordia su di noi. Eravamo tutti consapevoli che avremmo sofferto a causa di quel gesto. Dopo la preghiera, Blaurock si alzò e mi chiese di essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella sera fummo in quindici a battezzarci e da quella sera nulla fu più come prima.
lle nostre mancanze. Aiutaci a esserti fedeli, anche se questa fedeltà ci costerà il prezzo della croce. È nel nome di tuo Figlio, Gesù Cristo, che ti prego. Amen». Seguì un lungo silenzio e io tornai a sedermi. L’eco delle ultime parole di Zwingli, dopo la disputa sul battesimo che si era tenuta qualche giorno prima, ancora risuonava nelle mie orecchie: «Che intenzioni avete? Volete dividere la Chiesa?». George Blaurock si alzò. Si aggiustò alla meno peggio nel suo enorme cappotto blu e, con voce sonante – non a caso era chiamato “Giorgio il forte” –, scandendo ad una ad una le sue parole, disse: «Ma quali dubbi? Cosa c’è di più chiaro? Trovatemi un solo passo nella Bibbia in cui il battesimo viene amministrato a un bambino appena nato. Che cosa ci insegnano le parole di Cristo: Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato (Mc 16:16)? Io stasera non torno a casa se prima non sarò stato battezzato».Si sentirono più voci accavallarsi: sì, è vero, ha ragione il fratello George; sì, è proprio così che Cristo dice; ben detto fratello… «Silenzio», dissi, «silenzio», ripetei «dobbiamo esprimerci tutti e soltanto quando tutti avranno preso la parola, decideremo cosa fare». Anna, la più anziana del gruppo, parlò per prima: «Noi non possiamo ignorare il comandamento di Gesù Cristo. Io sono pronta. E sono certa che anche tutti gli altri, come me, lo sono. Vero?». Non aveva ancora pronunciato per intero la parola ‘vero’ che si era girata prima alla sua sinistra e da lì velocemente aveva guardato tutti noi negli occhi fino a fermarsi alla sua destra, lì dove era seduto Johann Broetli.Broetli si sentì interpellato da quello sguardo di Anna e disse la sua. Gli altri lo seguirono. Parlarono tutti e tutti furono concordi. Mi alzai in piedi nuovamente, sentii una misteriosa forza nei muscoli delle mie gambe, chiesi a Felix Mantz di portarmi una brocca d’acqua e un catino. Ci inginocchiammo e pregammo tutti, chiedendo a Dio di aiutarci a compiere il suo volere e ad avere misericordia su di noi. Eravamo tutti consapevoli che avremmo sofferto a causa di quel gesto. Dopo la preghiera, Blaurock si alzò e mi chiese di essere battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quella sera fummo in quindici a battezzarci e da quella sera nulla fu più come prima.
Gli altri presenti in quella stanza si voltarono verso di me. Io mi schiarii la voce ancora una volta. «Anna, prima di tutto grazie per la tua ospitalità e il brodo era veramente squisito». Tossii. Anna Mantz, sorridendo, mi disse: «Sono ben felice di ospitarvi a casa mia e la mia porta è sempre aperta». Al centro della stanza c’era una stufa a legna da poco accesa
Io restai in piedi, nonostante la pesantezza che sentivo alle gambe e iniziai a pregare: «Signore, mostraci qual è la migliore cosa da fare. Tu conosci i nostri timori e le nostre incertezze. Ma tu, Signore, ci hai dato in mano il tuo libro, la Bibbia, e noi l’abbiamo letta e ci siamo accorti de
L’articolo Una memoria che fa giustizia: i 500 anni di storia dell’Anabattismo proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/una-memoria-che-fa-giustizia-i-500-anni-di-storia-dellanabattismo/
Non confondere l’intelligenza con il valore
Con l’articolo di oggi (lunedì 27 ottobre 2025) iniziamo la pubblicazione di un piccolo dossier sull’intelligenza artificiale, pubblicato nel numero Luglio/Agosto della rivista Christianity today.
Gli articoli sono tradotti e pubblicati con il permesso di Christianity Today.
Cos’è l’intelligenza (artificiale)?
Quattro esperti si confrontano sulla conoscenza nell’era dell’IA.
Storicamente, i teologi hanno individuato diverse caratteristiche di ciò che significa essere creati a immagine di Dio: la razionalità, la capacità di amare e la giustizia umana prima della Caduta.
“Nella storia dell’interpretazione è stato fin troppo facile piegare questo termine estremamente aperto, ‘immagine di Dio’, al servizio del pensiero filosofico e religioso contemporaneo”, osserva lo studioso biblico David J. A. Clines.
Oggi torniamo a confrontarci con questo termine di fronte a un panorama tecnologico di robot quasi autonomi e grandi modelli linguistici (LLM). In molti sensi, ci stiamo chiedendo che cosa significhi essere umani. Soprattutto ora che l’intelligenza artificiale generativa avanza, potremmo iniziare a mettere in discussione il nostro posto nel mondo. Possiamo intrattenere relazioni interpersonali con ChatGPT? Se perdiamo il lavoro o il nostro mestiere a favore dell’intelligenza artificiale, scendiamo di rango nella catena sociale?
Le nostre domande non riguardano solo il lavoro, ma anche teologia ed etica. Come cristiani dobbiamo chiederci quale ruolo abbia l’intelligenza nell’imago Dei e se l’IA sia davvero intelligente. Non siamo né Dio, né animali, né macchine. Buona parte del mondo è strutturata per farci vivere in modo meno umano: come immaginare di riflettere Dio in un mondo sempre più tecnologico?
Per l’edizione cartacea di luglio/agosto, CT ha invitato un ingegnere software, un ricercatore, un imprenditore tech e un professore a riflettere su come definiamo l’intelligenza, sia nei calcoli matematici, sia nella nostra capacità di amare o di conoscere per esperienza.
Siamo umani, dopotutto.
(Kara Bettis Carvalho, editor della rubrica Ideas di Christianity Today).
1° Articolo
La nostra ossessione per le capacità dell’IA non comprende ciò che l’intelligenza è davvero.
(Chris Krycho)
Gran parte del dibattito contemporaneo sugli strumenti di intelligenza artificiale come i large language model (LLM) si concentra, in primo luogo, sul chiedersi se tali strumenti siano veramente intelligenti e, in secondo luogo, su cosa significhi tutto ciò per noi esseri umani, per il nostro lavoro, per l’arte e persino per le nostre relazioni. Per i cristiani, questi problemi sono spesso seguiti da domande o affermazioni sull’IA e l’imago Dei. Si tratta di interrogativi legittimi.
Io sostengo, però, che queste siano per lo più le domande sbagliate. Partono da presupposti errati su cosa sia l’intelligenza. Di conseguenza, portano con sé nozioni fuorvianti su cosa significherebbe per tecnologie come gli LLM essere veramente intelligenti.
Peggio ancora, queste domande non comprendono appieno il rapporto tra intelligenza e natura umana. L’intelligenza non è affatto una cosa unica. I test del QI ci ingannano perché suggeriscono che l’intelligenza sia misurabile e che un singolo numero rappresenti in modo significativo l’intelligenza.
Quei test catturano qualcosa di reale. Predicono con precisione, ad esempio, come le persone si comporteranno all’università e sono in generale indicativi delle probabilità di successo in un’economia basata sulla conoscenza.
Ma c’è molto che non catturano. Per capire cosa intendiamo, consideriamo questa domanda: gli elefanti sono più intelligenti dei delfini? Dipende dal tipo di azione che chiediamo loro di fare. Un elefante non può usare l’eco localizzazione per cacciare e catturare pesci, e un delfino non può usare il naso per cogliere frutti da un albero. Entrambe queste azioni implicano sicuramente tipi di intelligenza e sensi completamente estranei agli umani.
Allo stesso modo, alcuni sistemi software possono superare gli esseri umani in determinati compiti che consideriamo questioni di intelligenza perché li percepiamo come parte della nostra vita mentale. Queste operazioni includono calcoli matematici o persino giochi sofisticati come gli scacchi.
D’altra parte, il robot più avanzato non può (ancora) battere una persona in una partita di basket uno-contro-uno o arrampicarsi su un albero come uno scoiattolo. L’azione incarnata è ancora ben al di là delle nostre migliori capacità di programmazione, inclusa la famosa destrezza.
Tutto ciò mette in evidenza un modo in cui la visione della cultura occidentale sull’umanità è distorta: abbiamo dato all’intelligenza più importanza di quanto dovessimo. Valorizziamo le persone che creano software, scrivono libri o perseguono “la vita della mente”. Compiangiamo coloro che sono rimasti indietro nella transizione della società verso il lavoro della conoscenza; consideriamo il lavoro fisico umile invece di valorizzare la bontà intrinseca del lavoro corporeo.
Ma anche questo è riduttivo: trattare l’intelligenza come una semplice abilità. Gli esseri viventi, e gli umani in particolare, non sono macchine da compiti. Abbiamo fini più alti. Giocare intorno a un tavolo non «completa un compito». Neppure amare qualcuno lo fa!
Quindi, non possiamo dire cosa l’intelligenza in sé richieda da noi. Non solo l’intelligenza appartiene in misure diverse e con funzioni estremamente variabili a molte specie di creature; è anche il punto di partenza sbagliato per riflettere sugli obblighi etici.
In realtà, usare l’intelligenza altrui come fondamento dei nostri doveri etici è perverso. Implicherebbe che più uno è intelligente, maggiore è l’obbligo,e viceversa. Feti, persone con demenza progressiva o con gravi disabilità mentali richiederebbero meno attenzione di un brillante matematico, scienziato, compositore o poeta.
Il Signore invece ci insegna il contrario: «Quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l’avete fatto a me» (Mt 25: 40). I cristiani apprezzano e valorizzano ogni essere umano, qualunque sia la sua capacità, senza fissarsi sul talento intellettuale.
Potremmo cercare di cavarcela parlando di «capacità» anziché di «abilità». Esiste una tradizione – risalente a [epoca] – che collega l’immagine di Dio alla razionalità, cioè alla facoltà di ragionare e agire, piuttosto che alla sottomissione all’istinto. Tale tradizione distingue tra la capacità naturale propria di una specie e le sue eventuali assenze o distorsioni in singoli individui. Dobbiamo quindi distinguere tra la capacità generale di ragionare propria dell’uomo e la sua attuale abilità individuale
Nella sua forma più semplice, la razionalità è quella capacità di ragionare, e anche quella varia enormemente. Sia un neonato che una persona con demenza avanzata potrebbero non essere in grado di ragionare in questo senso, ma entrambi portano comunque l’immagine di Dio.
A prescindere dalle disabilità, ognuno possiede livelli molto diversi di intelligenza lungo i suoi molteplici assi. Non c’è motivo di ritenere che tali differenze siano frutto della Caduta o che saranno eliminate nella Risurrezione. È evidente se pensiamo a talenti fisici: correre o fare matematica complessa.
L’intelligenza quindi non è la stessa cosa della razionalità, e certamente non è identica all’immagine di Dio. Non dobbiamo confondere l’intelligenza effettiva con il valore della creatura o con l’immagine di Dio.
Quali sono, allora, le domande giuste? Una: che cosa significa essere umani. È un interrogativo antico, ma le nostre nuove circostanze possono aiutarci a porlo con maggiore attenzione. Un’altra: come valutare correttamente gli esseri umani – e forse anche le altre creature – non in base all’intelligenza, bensì alla loro creaturalità. Le risposte potrebbero indurci a rifiutare certe strade o a percorrerle in modo particolare.
Chris Krycho
Chris Krycho è ingegnere informatico e compositore. È membro della Holy Trinity Anglican Church e ha conseguito un M.Div. presso il Southeastern Baptist Theological Seminary.
L’articolo Non confondere l’intelligenza con il valore proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/non-confondere-lintelligenza-con-il-valore/
La scaturigine del dubbio nel paradosso dell’umano
di Giacomo Carlo Di Gaetano
Mark Meynell ci ha proposto, per il prossimo Convegno Sudi GBU (Montesilvano 5-8 dicembre, il 18° della serie), improntato anche quest’anno alla duplice esigenza di vivere e confrontarsi con …, una vera e propria mappa del dubbio. È questo il convitato di pietra di quest’anno: vivere e confrontarsi con il dubbio.
Si parte con il dubbio che ha a che fare con le limitazioni della nostra natura umana, di creature diremmo da credenti, anche se sappiamo che su questo punto, vale a dire le limitazioni che ci pongono nella condizione di dubitare, si può raggiungere una unanimità quasi universale. Credenti e non credenti, spiritualisti e animisti, tutti conoscono i limiti della propria condizione. Che si viva in Occidente o in un posto sperduto del mondo.
A nulla valgono, nei confronti dei limiti creaturali, i risultati e le acquisizioni del sapere scientifico. Anzi, si può dire che all’ombra dei progressi scientifici e tecnologici i dubbi sono aumentati. Si pensi all’indugiare di tutto il genere umano nei confronti del tema e della realtà dell’Intelligenza Artificiale.
Si passa poi a considerare i dubbi che sono insiti nelle credenze, in questo caso nelle credenze da cristiani. Qui il quadro si complica ulteriormente. A volte è stata usata la fede come antitesi alla condizione dubitante (ma come stanno insieme tre nomi in un’unica sostanza?). Credo quia absurdum! Oppure si è introdotto il tema del mistero come limite oltre il quale la ragione credente non deve avventurarsi. Oppure si parla di fideismo. E all’opposto molto spesso le convinzioni del credente hanno teso a raggiungere una forma di certezza. Di quale tipo? In ognuno di questi passaggi il dubbio è in agguato, sta dietro l’angolo. A volte può ravvivare la fede, a volte la può spegnere; ma è in–dubbio che qui ci muoviamo all’interno di cose che “crediamo” e che alimentano la nostra spiritualità.
Certo, un esito del dubbio credente può portare a un’altra categoria di dubbio, quella dello scetticismo. Il dubbio sfocia nell’incredulità. Si pensi a tutto il tema della verifica empirica o positiva delle credenze, tema che infiammò la ricerca scientifica e teologica di buona parte del XX secolo. Una ossessione che investì lo stesso linguaggio poiché se questo, il linguaggio, è un semplice rispecchiamento della realtà non può dire ciò che non si può rispecchiare, ergo verificare. Qui ci sono molti spunti di lavoro per l’apologetica cristiana.
In ultimo Meynell ci suggerisce una categoria del dubbio che un cristiano, per principio, non può accettare. Lo stolto ha detto nel suo cuore non c’è Dio. Che cosa c’è in quel “per principio non può accettare” è qualcosa che deve essere chiarito.
Come corollario giova segnalare un passaggio della prospettiva che Meynell ci anticipa, vale a dire una sorta di dubbio che sebbene possa manifestarsi nel campo delle emozioni e dei sentimenti, fino a generare veri e propri disagi sul piano psicologico e sociale, tuttavia richiama scenari più profondi. Meynell parla del dubbio suscitato dalla nostra indegnità, inadeguatezza. Rispetto a cosa, rispetto a chi?
Beh è facile a questo punto fornire un suggerimento saggio e caloroso: partecipate al Convegno per immergervi in questo turbinio di pensiere e di riflessioni. Crediamo che la Bibbia, predicata nella convinzione che costituisca il medium usato da Dio per parlarci, saprà fornirci una guida …
Tuttavia vale la pena, prima di chiudere questa riflessione e reiterare l’invito a partecipare al Convegno Studi GBU, segnalare un passaggio del capitolo del libro che Meynell porta con sé e di cui parleremo al Convegno, Un deserto di specchi. Tornare a credere in un mondo segnato da subbi sospetti e scetticismo.
L’espressione “deserto degli specchi” è presa dal linguaggio dello spionaggio e delle spie e richiama l’impossibilità di posare lo sguardo su fatti che non siano essi stessi riflesso di qualcos’altro. Il rischio è che se rompessimo tutti gli specchi, alla fine, scopriremmo di essere in un desolato deserto.
L’autore usa l’immagine per rilevare il clima di generale sospetto che circonda istituti e realtà una volta ritenuti altamente affidabili: i governi, la politica, la scienza, la chiesa. È il trionfo del complottismo. Il libro per certi versi è profetico poiché, scritto precedentemente alla pandemia di covid, anticipa il clima che si è magnificato nelle battaglie no-vax e in altre forme di complottismo.
Questo clima l’autore lo riconduce alla fondamentale paradossalità della condizione umana. Il capitolo sesto, intitolato suggestivamente Un’antica ermeneutica del sospetto, richiama la visione biblica dell’essere umano, quella a cui ha attinto a piene mani un filosofo come Blaise Pascal, quella in cui possiamo dire grazie perché l’uomo non è come un bruto (l’imago dei), ma quella stessa visione in cui la pretesa di Vivere nel Mondo di Dio Come se fosse Mio ha moltiplicato la teologia del serpente (o serpentismo) che è alla base del meccanismo del dubbio.
È il paradosso la matrice di ogni dubbio.
Questa interpretazione dell’essere umano (ermeneutica la definisce l’autore) è plausibile e permette un approccio realistico a sospetti, dubbi e scetticismo. Solo partendo dalla plausibilità di questa lettura dell’umano, una lettura che solo la Bibbia sembra garantire, solo partendo da lì, abbiamo la speranza di venire a patti con il dubbio, di vivere e confrontarci con il dubbio.
L’articolo La scaturigine del dubbio nel paradosso dell’umano proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/la-scaturigine-del-dubbio-nel-paradosso-dellumano/
Perché, Signore, nascondi il tuo volto?
di Vinoth Ramachandra
(Il riso di Sara. Dubbio, lacrime e speranza cristiana, Edizioni GBU, 2025 – Collana Il duplice ascolto)
«Chi crede di credere in Dio, senza però passione nel suo
cuore, senza angoscia nella sua mente, senza incertezze,
senza subbi e perfino, a volte, senza disperare, crede solo
nell’idea di Dio, non in Dio stesso» (M. de Unamuno)
«Fino a quando griderò, o Signore, senza che tu mi dia
ascolto? Io grido a te: “Violenza!” e tu non salvi. Perché mi
fai vedere l’iniquità e tolleri lo spettacolo della perversità? … (Abacuc)
Le parole di Abacuc sono state costantemente sulle mie labbra durante la sanguinosa guerra civile dello Sri Lanka iniziata nei primi anni ‘50 del XX secolo e giunta alla sua brutale conclusione soltanto nel 2009. Quella iniziata negli anni ‘50 dalla minoranza tamil del nord come una legittima battaglia per i diritti civili, è sfociata poi nella violenta pretesa di uno stato tamil separato ed è rapidamente degenerata in un’incessante spirale di vendette dominata dalla legge del taglione. Più di centomila persone hanno perso la vita; non si contano quanti, rimasti senza casa, sono fuggiti dal paese come rifugiati.
Com’è normale in tali conflitti violenti, sono state commesse terribili atrocità e spaventose violazioni dei diritti umani sia dai guerriglieri separatisti tamil sia dall’esercito regolare. Nessuna delle rimostranze all’origine della guerra è ancora stata presa in considerazione né i responsabili di crimini di guerra e violazioni dei diritti umani hanno dovuto rispondere alla giustizia. Lo Sri Lanka è solo uno dei tanti paesi, spesso ricchi di bellezze naturali e forti di una nobile eredità culturale e religiosa, rovinati da politici corrotti e incapaci e da nazionalisti religiosi assetati di potere. Ci sono anche numerose «guerre dimenticate»; se ne combattono di continuo in ogni angolo del mondo ma raramente se ne dà notizia nei canali di news internazionali, per non parlare dei social.
Messi in ginocchio dal conflitto, questi stati sono spesso ricchissimi di risorse, cosa che ha indotto alcuni economisti dello sviluppo a parlare di questi paesi definendoli affetti dalla «maledizione delle risorse». Il combinato di una governance debole e di una grande abbondanza di risorse naturali, promessa di un veloce arricchimento a chi ne controlli la produzione e l’esportazione, è una delle principali cause di violenti conflitti. I diamanti in Angola e Sierra Leone, la legna e i diamanti in Liberia, le pietre preziose in Afghanistan, rame, oro, cobalto e legna nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati tutti al centro di guerre civili. La miniera di Grasberg nella Papua occidentale, la più grande miniera d’oro nonché seconda miniera di rame al mondo, è posseduta dalle società minerarie Freeport McMoran e Rio Tinto, in una delle regioni più povere dell’Indonesia, al momento testimone della nascita di un movimento di guerriglieri separatisti. L’Angola vanta il secondo posto in Africa per estensione dei suoi giacimenti di petrolio, nonché il quarto al mondo per estensione dei suoi giacimenti di diamanti. La sua enorme ricchezza naturale è stata utilizzata per alimentare una guerra civile dove, fra il 1975 e il 2002, un milione di persone sono rimaste uccise o mutilate, mentre altri quattro milioni sono sfollati all’interno del paese. Tre anni dopo la fine della guerra si è classificato 160° su 177 paesi nell’Indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, con un’aspettativa media di vita di quarant’anni.
Il costo complessivo di tali conflitti non può essere colto dalle sole statistiche (i cui dati, comunque, sono spesso molto meno affidabili in paesi dove sia in corso un violento conflitto). I costi umani immediati, per quanto enormi, rappresentano solo una minima parte del prezzo pagato da questi paesi alla guerra. In conflitti di lunga durata, intere generazioni di bambini e giovani sono oppresse dagli effetti della guerra. Famiglie e comunità lasciano in eredità ai posteri il trauma degli abusi sessuali, dei saccheggi e delle morti violente. Le devastazioni degli habitat naturali e i blocchi nella produzione di cibo e nei mercati locali portano a una diffusa malnutrizione; i progressi nel campo della sanità e dell’istruzione rischiano di essere vanificati.
Donne e bambini sono particolarmente vulnerabili. Le donne soffrono la brutalità delle violenze e degli abusi sessuali, durante e dopo il conflitto. In anni recenti, sono stati documentati degli stupri di massa in Bosnia–Erzegovina, Cambogia, Liberia, Perù, Somalia e Uganda [per non parlare dei conflitti che hanno fatto seguito alla stesura di questo libro: guerre successive all’11 Settembre, Ucraina e Gaza, nde]. Molte di queste donne continuano a soffrire di traumi prolungati, aggravati dall’ostracismo da parte della famiglia e della comunità allargata. È un dato ormai assodato: in molte situazioni di conflitto, la violenza contro le donne è una strategia istituzionalizzata adottata dalle fazioni in guerra, comprese le forze governative.
Gli abitanti dei paesi ricchi sono legati a filo doppio con le comunità dei paesi poveri, dove le vite sono devastate dal conflitto. Il traffico internazionale di droga e il mercato illegale delle armi forniscono il supporto finanziario e le armi da cui questi violenti conflitti sono alimentati.
Sul piano personale, mia moglie Karin è morta sei mesi prima della mia visita alla mostra di Londra sull’influenza del 1918–1919. Nel suo ultimo sermone nella nostra chiesa, subito prima del Natale del 2017, ha inquadrato i disturbi dovuti al cancro da cui era affetta e la sua imminente morte nella prospettiva storica del cantico di Maria, il Magnificat: un giorno il Salvatore rimetterà a posto il mondo ma nel frattempo noi dobbiamo convivere con tanti quesiti irrisolti. Maria ha accettato il biasimo sociale derivante dal fatto di essere rimasta incinta senza essere ancora sposata e anche la prospettiva di perdere il figlio, destinato a morire giovane. All’inatteso sopraggiungere di un’afflizione, quasi tutti ci chiediamo:
«Perché a me?». Come sottolineato da Karin, però, dovremmo piuttosto chiederci: «Perché non a me?». Dopo tutto, viviamo in un mondo messo sottosopra, dove uomini, donne e bambini muoiono di continuo per incidenti, violenze, malattie, fame o a causa di qualche disastro naturale. Cristo non ci ha mai promesso di esserne immuni. Come cristiani, siamo parte di un’umanità sofferente, ancora in attesa di redenzione.
Le domande sulla sofferenza, però, possono essere assillanti e spesso possono arrivare a paralizzarci. La sofferenza, poi, non deriva solo dalla perdita di una persona cara ma dalla perdita della salute, del lavoro e della reputazione; dall’infertilità e dalla disabilità; inoltre, dalla spiacevole presa di coscienza dell’impunità spesso goduta dall’ingiustizia e dall’empietà. Nella Seconda Lettera di Pietro, leggiamo di Lot, nipote di Abramo, abitante delle antiche città di Sodoma e Gomorra, «rattristato dalla condotta dissoluta di quegli uomini scellerati (quel giusto, infatti, per quanto vedeva e udiva, quando abitava tra di loro, si tormentava ogni giorno nella sua animagiusta a motivo delle loro opere inique)» (2 Pt 2:7–8).
Tutta la Bibbia è percorsa da una lunga, ricca e spesso ignorata tradizione di lamenti. Incomincia con le sconcertanti parole attribuite a Dio stesso nei primi capitoli della Genesi: «Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì d’aver fatto l’uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo» (Gen 6:5–6). Culmina nel grido dei martiri intorno al trono di Dio nella visione del veggente Giovanni: «Fino a quando aspetterai, o Signore santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» (Ap 6:10)
L’articolo Perché, Signore, nascondi il tuo volto? proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/perche-signore-nascondi-il-tuo-volto/
La Via Dolorosa vs Wall Street
di Mark Meynell
(Mark Meynell sarà il relatore al 18° Convegno Studi del GBU (5-8 dicembre, Montesilvano -PE- “Vivere e confrontarsi con il dubbio“)
Il brano è tratto dal libro dell’autore, che sarà presentato al Convegno, dal titolo Un deserto di specchi. Tornare a credere in un mondo segnato da dubbi, sospetti, cinismo e scetticismo
Al pari di ogni nuovo movimento, religioso o di altra natura, i primi cristiani idearono un nome per la loro nuova fede. Era nota semplicemente come «la via», parola comune che poteva voler dire indifferentemente “sentiero” oppure “strada” (At 9:2; 19:23; 24:14). Fu una scelta ingenua. Ogniqualvolta facevano agli altri degli appelli perché credessero in Gesù, tutto quello che stavano facendo era invitarli a unirsi a loro nella stessa strada che stavano percorrendo. Di certo non v’era alcun senso di superiorità o di sufficienza, rendendo chiaro che al pari della vita, anche l’esperienza della fede in Cristo è un viaggio. Nessuno sulla via poteva asserire di avercela fatta, di essere arrivato. La cosa aveva pertanto una sua forza attrattiva, la cui migliore sintesi è l’adagio per definire l’evangelismo: si tratta «semplicemente di un pezzente che mostra a un altro pezzente dove trovare il pane».
Per vedere come il rapporto della chiesa ufficiale con il potere pubblico cambiò rispetto ai primi decenni della via, dobbiamo tornare all’imperatore romano del quarto secolo considerato nel capitolo 7 (Qualcuno di cui fidarsi. Il potere in mano sicure).
Costantino emerse vittorioso da una lotta per il potere imperiale. Calcolò spregiudicatamente che un Cristianesimo assurto al rango di religione ufficiale dell’Impero avrebbe calzato a pennello ai suoi bisogni politici. Analogamente, i cristiani riconobbero quanto fosse vantaggioso sostenerlo contro i suoi rivali, per nulla empatici nei confronti della via[1]. Da allora, come osservato da Graham Tomlin, «il Cristianesimo nel mondo occidentale ha cercato d’influenzare la società da una posizione di forza»[2]. Fu l’inizio di quello che divenne noto come Cristianità. Naturalmente, si evolse in un lungo periodo di tempo ma l’editto di Costantino ebbe conseguenze memorabili.
L’imperatore aveva fretta di giungere a una decisione definitiva sulla cristologia, non necessariamente perché avesse forti convinzioni in un senso o nell’altro ma perché la confusione remava contro i suoi programmi politici. Di fatto, rimproverò entrambi gli uomini al centro del dibattito (Ario e il vescovo Alessandro di Alessandria) per essere causa di tanti problemi. Così, nel 325 d.C., convocò a Nicea circa milleottocento vescovi da tutto il mondo per il primo grande concilio della chiesa, anche se forse riuscirono ad arrivarci solo in trecento. La successiva professione del concilio (nota come Credo niceno) proclamò solennemente la natura congiuntamente umana e divina di Cristo. Lungi dall’essere un’imposizione del potere imperiale, questo fu un esempio di come i cristiani misero ordine in casa loro su un tema di estrema importanza.
I veri problemi, in realtà, sopraggiunsero dopo. Una cosa era sconfessare le posizioni di Ario (secondo cui Gesù sarebbe stato soltanto umano e non divino) in quanto incompatibili con la fede cristiana; c’era in questa posizione una contraddizione fondamentale. Altra cosa però fu l’esiliò da parte di Costantino dei due vescovi ariani che avevano votato contro il riconoscimento della divinità di Gesù.
Il rapporto fra chiesa e stato risultò così per sempre compromesso.
Da allora è stata una strada a doppio senso. La chiesa si accorse della scorciatoia offerta dal facile accesso ai corridoi del potere per la realizzazione dei propri obiettivi. Anche a Costantino conveniva: tornava utile l’asserzione, da parte della chiesa, secondo cui la sua vittoria doveva essere stata opera della divina provvidenza. Con questo non si vuole negare che debba essere stata davvero la provvidenza divina a produrla (questo è un corollario della fede in un Dio sovrano). Tutt’altra cosa, però, è insinuare una legittimazione, da parte della divina provvidenza, di ogni avventura di un sovrano, non più di quanto votare per un candidato significhi sottoscrivere tutto quanto quel candidato fa mentre è al potere.
Paolo, per citarne uno, è molto bravo a capovolgere quest’idea. Asserisce polemicamente che le autorità del mondo sono stabilite da Dio e dunque si dovrebbe ubbidire alla legge (Rom 13:1–7). Tutto questo però implicava una sua personale approvazione di tutto quanto fatto o promosso da Roma? No di certo! Inoltre, che cosa potrebbe esservi di più politicamente sovversivo dell’asserzione secondo cui Gesù è il Signore (1 Cor 12:3)? Fin dall’inizio, dunque, Paolo proclama l’esistenza di chiari limiti all’ubbidienza civile. Se mai lo stato cercasse di calpestare la supremazia di Cristo, la disubbidienza non sarebbe soltanto consigliabile; sarebbe obbligatoria. Non è mai all’ordine del giorno se Gesù sia dalla parte di un certo candidato, una certa causa o un dato credo. Ben più importante è se loro siano o meno dalla sua. Ecco perché è sempre preoccupante quando un gruppo, uno stato o anche, mi sia consentito azzardare, una denominazione ecclesiastica, rivendica il possesso di un mandato esclusivo per il cielo. Gesù non avrebbe mai potuto essere comunista, capitalista, conservatore, liberale, modernista o postmodernista, femminista, relativista, individualista, democratico o imperialista, monarchico o repubblicano. Scegliete pure la vostra causa; Gesù non ne fa parte. Il ché, però, non significa che non ci siano in alcune o anche in tutte queste idee, degli aspetti in qualche modo coerenti con una visione del mondo cristocentrica (tutti aspetti di cui, nel corso dei secoli, i cristiani sono stati annoverati fra i promotori).
Da allora, sotto molte forme culturalmente diverse, la chiesa si è incamminata lungo un pericoloso sentiero politico. Più i leader cristiani sono stati vicini al potere costituito, meno il loro ministero è risultato profetico. Non che la signoria di Cristo non abbia risvolti nella sfera politica. Se davvero Gesù è il re dei re (p.es., 1 Tm 6:15; Ap 19:16), ogni altra autorità è inevitabilmente rimpicciolita e relativizzata. Non desta stupore la quantità di megalomani che hanno odiato Cristo.
La cautela verso il potere imperiale non è comunque una giustificazione per silos cristiani. Tutt’al contrario. La signoria di Cristo dovrebbe ispirare e influenzare profondamente l’azione in tutti gli ambiti di vita. Martin Lutero applicò esplicitamente l’inno cristologico della Lettera ai Filippesi al modo con cui i principi tedeschi avrebbero dovuto governare: «Il principe svuoti pertanto sé stesso del proprio potere e della propria supremazia nel suo cuore e si preoccupi dei bisogni dei suoi sudditi come se fossero i suoi bisogni. Questo, infatti, è quanto Cristo ha fatto per noi e questa è una vera opera d’amore cristiano»[1]. Eppure, nemmeno Lutero riuscì a percorrere con coerenza questo difficile sentiero. Troppo spesso la chiesa ha consentito alla sua missione di essere indistinguibile da quella dello stato, invece di proclamare la verità al potere anche quando farlo avrebbe potuto minacciare i suoi privilegi. Dopotutto, Gesù fece proprio questo quando fu interrogato da Pilato.
Come potrebbe non essere questa la ragione per cui oggi si fa di tutt’erba un fascio fra la chiesa e ogni altra istituzione umana? Le persone nutrono il comprensibile sospetto che la ciesa abbia agito proprio come ogni altra istituzione. Avendo goduto per secoli di uno status privilegiato in Occidente, grazie al quale ha spesso dominato sugli altri e a volte li ha soggiogati, una cosa, così come ipotizzato da Graham Tomlin, è certamente essenziale: la chiesa deve ripensare «la sua nozione di potere e il modo con cui opera, se vuole giocare un ruolo significativo in questo mondo post–autoritario»[2].
Quest’appello non è motivato da un cinico pragmatismo ma dal desiderio di ritrovare l’antico modello di potere autenticamente cristiano, nello sforzo al tempo stesso di mantenersi fedeli a Cristo e di offrire a un mondo dominato da isolamento e diffidenza una vera alternativa al deserto di specchi. È un appello ai credenti perché percorrano la via e chiamino altri a unirsi loro e fare lo stesso. Questo cammino non è la strada del potere e del successo ma l’impervio sentiero del sacrificio e dell’amore. Quando Gesù ha chiamato gli altri a seguirlo prendendo una croce (Mc 8:34), non voleva dire che i suoi discepoli dovessero morire per il peccato; si limitò a preconizzare l’esperienza dell’incomprensione e del disprezzo da parte del mondo in cui i discepoli sarebbero stati accomunati a lui.
A Gerusalemme c’è ancora una strada di nome Via Dolorosa, in quanto ritenuta la strada lungo la quale Gesù s’incamminò con passo malfermo verso la crocifissione È questa la strada lungo cui la chiesa deve incamminarsi. Invece, siamo tanto attratti da altre strade per i nostri modelli di potere. Sotto l’Impero britannico, la chiesa è stata spesso simile alle due autorità londinesi ubicate a Whitehall (sede del Governo) e sulla strada il cui nome presenta qualche curiosa eco biblica, Threadneedle Street sede della Banca dInghilterra [Il nome è composto dalle parole inglesi per filo e ago, forse in quanto anticamente sede di fabbriche di aghi; l’autore fa evidentemente riferimento al monito di Gesù in Mt 19:24 e riff., ndt].
Gli influssi odierni provengono più verosimilmente da Pennsylvania Avenue, Hollywood Boulevard, Wall Street e Madison Avenue. Le ultime mode in politica, intrattenimento, economia e management o marketing e comunicazioni plasmano probabilmente il modus operandi odierno della chiesa non meno di quanto il paternalismo imperiale britannico lo facesse più o meno un secolo fa.
Non intendo ignorare le numerose e felici eccezioni a questo trend o insinuare che la chiesa non abbia nulla da imparare da queste «strade». Il punto è semplicemente: da dove vengono i programmi, i metodi e il carattere della chiesa? In definitiva, tutte queste strade seguono il percorso opposto a quello della Via Dolorosa. Come la storia della chiesa insegna, ogniqualvolta la chiesa se n’è dimenticata, il messaggio di un re crocifisso chino a lavare i piedi è impercettibilmente ma inesorabilmente messo ai margini.
[1] Citato in R. Haydon Mitchell, Church, Gospel, and Empire: How the Politics of Sovereignty Impregnated the West, Wipf and Stock, Eugene, 2011, p. 183.
[2] G. Tomlin, Power of the Cross, op. cit., p. 312.
[1] R. Stark, Rise of Christianity, op. cit., p. 11.
[2] G. Tomlin, Power of the Cross, op. cit., p. 31.
L’articolo La Via Dolorosa vs Wall Street proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/la-via-dolorosa-vs-wall-street/
Servi per amore di Gesù
di Daphne Manlapaz (coordinatrice GBU Torino)
Quando mi hanno proposto di partecipare alla Formazione, mi sono fatta subito un’idea di come sarebbe stata: avremmo letto la Parola, ricevuto un insegnamento, partecipato a seminari e pregato. La mia aspettativa era giusta, ma Dio mi ha dato molto di più: mi ha donato una comunità, una famiglia. Ognuno di loro è stato per me ciò che Paolo è stato per i Corinzi: uno specchio della gloria di Dio, che riflette la luce del Padre.
Costretti dall’amore di Dio
Ciò che ha riunito tutti noi, studenti e staff da tutta Italia, in un hotel di Rimini è stato l’amore di Dio che opera in noi. Il Suo amore, nelle nostre città e nei nostri GBU locali, ha prodotto speranza per le persone che avremmo incontrato dopo. Come scrive Paolo in 2 Corinzi 5:14, l’amore di Cristo ci spinge: il pensiero del vangelo e l’amore che proviamo per Dio non riescono a contenere il nostro desiderio di condividere il vangelo e parlare dell’amore che noi per primi abbiamo sperimentato.
Il tema
Durante la Formazione abbiamo letto e meditato dal terzo al quinto capitolo della Seconda Lettera ai Corinzi. In questi capitoli, Paolo ricorda ai Corinzi chi sono in Cristo, chi è Dio per loro e come sono chiamati a vivere per amore di Gesù.
Paolo inizia affrontando un dubbio che alcuni avevano nei suoi confronti: la sua autorità era davvero valida? Per rispondere, li conduce a riflettere su se stessi e sul cambiamento che il vangelo ha prodotto nelle loro vite. Il vangelo, infatti, trasforma i cuori. Ma non solo: il vangelo è anche la luce della gloria di Dio, una luce che si riflette in noi e che gli altri possono vedere. Non siamo noi a dover dimostrare questa gloria, perché è Dio stesso a manifestarla attraverso di noi, anche nella sofferenza. E la nostra sofferenza, per quanto reale, è “leggera e momentanea”, perché mentre l’uomo esteriore si consuma, quello interiore si rinnova di giorno in giorno per la grazia di Dio.
Consapevoli di questa grazia, pienamente rivelata nella morte di Gesù, Paolo ci invita a vivere una vita con lo sguardo fisso su Cristo e a condividere questa vita come testimonianza dell’amore di Dio.
Come vasi di terra
Quest’anno non ero l’unica a partecipare per la prima volta alla Formazione e ad affrontare il nuovo anno accademico come coordinatrice: eravamo in molti. E penso che tutti noi, di fronte alla domanda “Vuoi essere coordinatore?”, ci siamo chiesti: “Sono davvero all’altezza?”. Ricevere e ricordare le parole di Paolo ci ha rassicurati: non è per le nostre forze o capacità che possiamo servire, ma per la potenza di Dio. Dio, come un vasaio, ci ha resi vasi di terra (che oggi potremmo paragonare a semplici bicchieri di plastica biodegradabile): fragili, di poco valore materiale.
Eppure, come scrive Paolo, noi non siamo vasi vuoti: portiamo dentro di noi un tesoro, il vangelo. Lo abbiamo sperimentato personalmente, e i nostri cuori sono la prova vivente che Dio ha scritto, e continua a scrivere, la nostra storia.
Ora, terminata la Formazione, siamo pronti ad affrontare il nuovo anno accademico con speranza, fiducia e franchezza, consapevoli della forza che il vangelo porta in noi.
Stesso Spirito di fede
Questo cambiamento di postura l’ho potuto vedere con i miei occhi, nei cuori di ciascuno di loro. Ho visto cuori aperti in adorazione, che invitavano Dio a dimorare dentro di sé. Ho visto Dio operare in ognuno, donando coraggio e forza per affrontare ciò che sarebbe venuto. Ho visto che non solo Dio era con noi, ma ciascuno di noi era lì per l’altro: ognuno incoraggiava il fratello o la sorella con la preghiera e con parole di speranza e di fede. Eravamo uniti in Cristo, animati dallo stesso Spirito di fede. E se non è stato Dio a renderlo possibile, chi altri avrebbe potuto? In pochi giorni, quella stanza d’albergo è diventata una casa, perché lo Spirito di Dio dimorava con noi. E quelle persone, ognuna con la propria storia e il proprio passato, sono diventate fratelli e sorelle in Cristo. La Formazione sarà anche finita, sì, ma il nostro amore per Dio no.
Ora ciascuno di noi è tornato al proprio GBU locale, lontano dagli altri rispetto a quando eravamo a Rimini. Eppure li sento tutti vicini, in spirito e nel cuore. Ognuno sta affrontando un nuovo anno e situazioni diverse, ma il Padre a cui ci rivolgiamo è lo stesso, e il Suo amore continua ad abbondare su ciascuno di noi, nelle nostre vite uniche e differenti. La Formazione è finita, sì, ma il nostro spirito di fede non lo sarà mai.
Gli occhi sulla Terra. Alcune considerazioni sul conflitto israelo/palestinese
Tempo di lettura: 6 minuti
Ecco, un re regnerà secondo giustizia e i principi governeranno secondo il diritto.
Ognuno sarà come un riparo contro il vento e uno schermo dall’acquazzone,
come canali d’acqua in una steppa, come l’ombra di una grande roccia su arida terra.
Non si chiuderanno più gli occhi di chi vede e gli orecchi di chi sente staranno attenti.
Isaia 31:1-3
Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo,
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo.
Apocalisse 21,2
La Palestina è la nostra patria storica, indimenticabile. Questo nome da solo sarebbe un
richiamo di trascinante potenza per il popolo nostro. Se Sua Maestà il Sultano cі desse la.
Palestina, ci potremmo in cambio impegnare a sistemar completamente le finanze della Turchia;
per l’Europa rappresenterebbe colà un pezzo del vallo contro l’Asia, copriremo l’ufficio di avamposti
della civiltà contro le barbarie; come Stato neutrale, rimarremo in relazione con l’Europa intera,
la quale dovrebbe garantire la nostra esistenza; per i luoghi santi della Cristianità si
*potrebbe trovare una forma di extraterritorialità garantita dal diritto internazionale:
noi saremmo la guardia d’ onore dei luoghi santi e risponderemo con la nostra esistenza
dell’ adempimento di un simile dovere.
Negli ultimi mesi, come molti di noi, ho assistito in parte attonito, in parte incredulo, a quello che è successo in Palestina. Va detto che per comprendere il tutto bisogna andare indietro nel tempo e capire cosa è successo probabilmente negli ultimi centocinquant’anni a proposito dell’eventuale presenza su quel territorio di uno Stato-Nazione che potesse essere ospitale per il popolo ebraico.
Sappiamo come questo sia divenuto realtà dopo il 1948 anche, con tutta probabilità, dopo quanto di tremendo era successo al popolo ebraico durante il Nazismo ed anche a seguito dell’attuazione parziale del mandato che la Gran Bretagna aveva avuto nel 1920 dopo la fine del primo conflitto mondiale e dopo la risoluzione delle Nazioni Unite del 1947.
La storia ci insegna che nonostante queste due decisioni (che possiamo anche definire coloniali ma che cercavano di portare stabilità al territorio ed al popolo ebraico) non hanno sortito gli effetti dovuti.
Esula da quest’articolo analizzare la travagliata storia del territorio della Palestina in questi decenni, ma sicuramente chi ne ha memoria (a quanto pare in Italia non molti) sa che le circostanze ed il quadro è sempre stato piuttosto complesso ed anche da studioso di storia dare un giudizio finale sulla situazione appare piuttosto difficile.
Nelle ultime settimane qui in Italia, però, vi è stata una mobilitazione sull’ultimo conflitto israelo/palestinese (quello che, ora, speriamo termini, avvenuto dopo l’attento di Hamas del 7 ottobre 2023). Le manifestazioni che ci sono state (con numerosi partecipanti) sono state tutte a favore della fine del conflitto ed a favore del riconoscimento di uno stato palestinese. Molto interesse ha anche destato l’impresa (assolutamente simbolica) della Global Flotilla che voleva rompere l’embargo degli aiuti portati a Gaza solo tramite canali ufficiali e sicuramente in maniera insufficiente (almeno sino ad ora).
Non va anche dimenticato che ormai da diversi mesi una parte dell’opinione pubblica italiana parla ed ha parlato per quanto riguarda Gaza di un genocidio programmato dei Palestinesi da parte dello stato israeliano, dove sicuramente vi sono esponenti del Governo che pensano che i Palestinesi non dovrebbero abitare quel territorio.
Notoriamente il mondo evangelico italiano e non solo (soprattutto quello più conservatore) si è schierato sempre a favore di Israele. Questo schieramento è dovuto a diversi fattori: da una parte la teologia di stampo più dispensazionalista ha sviluppato una teologia della restituzione (all’interno del piano di salvezza) in cui l’attuale Israele sarebbe uno Stato che fa parte del piano di Dio, dall’altra (questo soprattutto per l’Italia) una comunanza di appartenenza ad una minoranza religiosa che subito persecuzioni (anche se gli evangelici non nella stessa misura).
Cosa pensare dell’attuale situazione e da dover partire per una valutazione dei fatti?
Intanto vogliamo ribadire una cosa. Se il nostro recinto e la nostra priorità è quello dell’annuncio del Vangelo, è anche lecito su una questione politica o penultima avere delle idee diverse. Allo stesso tempo vanno fatte una serie di precisazioni a proposito di quanto accaduto. Cercheremo di andare in ordine.
Proprio per questi motivi i nostri interrogativi e le nostre osservazioni devono essere improntate ad una lettura chiara del messaggio biblico. Il testo biblico in tutt’e due le sue parti fa chiari appelli alla pace che non hanno a che fare solo con la pace spirituale ma anche con quella concreta. In questo senso una lettura del testo di Rubboli I cristiani, la violenza e le armi (che è stato scritto più pensando ad un contesto europeo e penso più a quello che succedeva in URSS ed Ucraina) ci può dare delle utili indicazioni sull’argomento.
Anche la tradizione storico-teologica evangelica può essere importante per comprendere come l’opzione di una pacificazione delle parti e di una riconciliazione (che sembra stia avvenendo). Bisogna ricordare che il diritto internazionale, la ricerca di una pace perpetua, prima che in Kant era in mente ad autori come Althusius (un importante giurista calvinista), Grozio (arminiano ed il primo che ha scritto un trattato di diritto internazionale) e William Penn (uno dei pensatori Quaccheri che ha fondato la Pennsylvania e che voleva la riconciliazione tra le nazioni europee). Tutti questi pensatori (ripresi in parte dal libro del docente pisano Tommaso Greco Critica della ragion bellica) parlavano dell’importanza del senso di comunità, dell’essere “giusti” pur in tempo di guerra e della possibilità di avere organismi internazionali che abbiano come loro priorità la pace. Tutte queste fonti, insieme al testo biblico, devono essere fonti di ispirazione quando ci troviamo in una situazione delicata come quelle di un conflitto che, talvolta, parrebbe assumere anche toni escatologici per il luogo in cui si svolge. Siamo per questo motivo contenti che si stia trattando e si sia arrivati ad un cessate il fuoco nella zona, perché riteniamo che la pace e la riconciliazione siano le chiavi giuste di risoluzione di un conflitto e questo a prescindere dalla parte che propone tutto ciò.
Noi come evangelici dobbiamo essere attenti alle sofferenze del mondo, al bisogno di aiuto ed al grido che viene dai popoli. Allo stesso tempo questo non ci deve impedire di continuare ad annunciare il Vangelo anche in tempi che sembrano bui.
Di fronte alla disperazione del mondo, bisogna contrapporre le parole di Isaia e dell’Apocalisse che predicano speranza, piuttosto che rassegnazione e rabbia anche in momenti difficili. Chiudo il testo ricordando proprio le parole di Herzl quando si adombrava alla fine del XIX secolo che una parte della Palestina potesse diventare la loro terra, non pensava ad un mondo in conflitto, ma ad un mondo riconciliato, come noi credenti vogliamo e dobbiamo volere quando parliamo di questa terra martoriata.
Valerio Bernardi – DIRS GBU
L’articolo Gli occhi sulla Terra. Alcune considerazioni sul conflitto israelo/palestinese proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/gli-occhi-sulla-terra-alcune-considerazioni-sul-conflitto-israelo-palestinese/
A quelli della “riserva” siate unici! 3/3
Tempo di lettura: 5 minuti
di Glen Scrivener
L’aria che respiriamo. Il cristianesimo, la libertà, l’educazione, il progresso e l’uguaglianza
Edzioni GBU 2025
Ho scritto questo libro rivolgendomi a tre tipologie di lettori [a tre interlocutori]:
Quelli della “riserva”
Gesù non ha mai sofferto d’ansia per le dimensioni o le prospettive del suo movimento. In Matteo 5 il gruppetto dei suoi seguaci era piccolo e insignificante e la sua morte ignominiosa era imminente, eppure la sua fede nel successo globale era incrollabile. A Cristo non interessava tanto la crescita della sua chiesa (ci sarebbe stata e lui lo sapeva) quanto la sua unicità.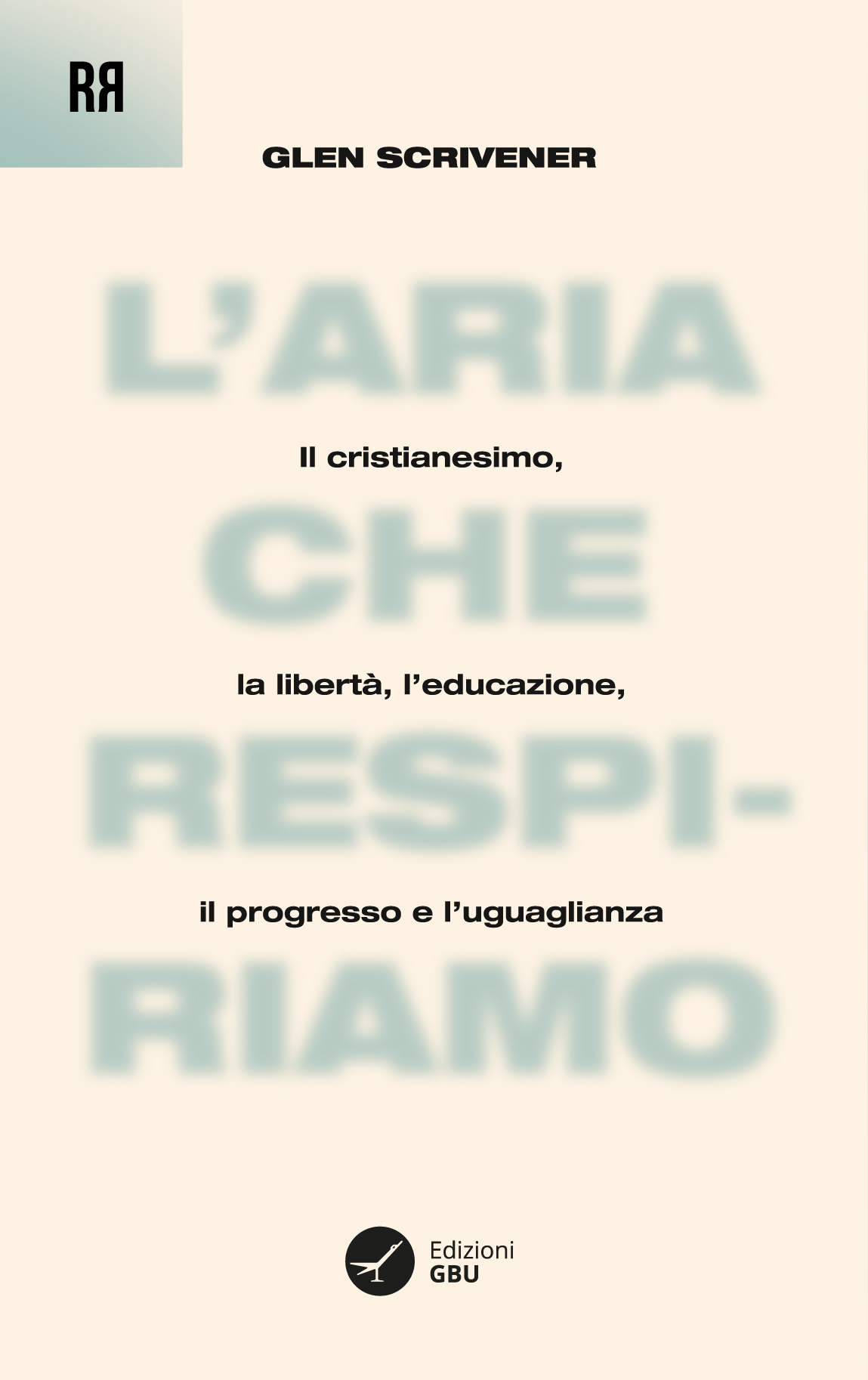 .
.
«Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini.
Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5:13–16).
Il “sale”, “una lampada”; realtà apparentemente insignificanti che tuttavia, per loro natura, diffondono in lungo e in largo la loro influenza. Così è della chiesa. Come il sale, la chiesa ha proprietà conservanti; non conserverà semplicemente la carne (come faceva il sale nel mondo antico) ma tutta la terra. Come luce, la chiesa brillerà illuminando il mondo.
Sale e luce, però, sono influenti proprio perché sono diversida quanto li circonda. Il sale deve essere salato e la luce brillante. Un sale privo di salinità è inutile, proprio come è inutile una lampada posta sotto un cesto. Il più grande bisogno della chiesa, perciò, è di essere unica, per essere se stessa. Non deve essere come la carne; non deve essere come le ombre
circostanti. Terminiamo su questa nota in quanto la tesi portata avanti in questo libro potrebbe facilmente essere fraintesa. Dopo dieci capitoli in cui è stata mappata l’enorme influenza del cristianesimo sul mondo, forse qualcuno penserà: «Il mondo è sostanzialmente proprio uguale alla chiesa e viceversa» (cosa palesemente non rispondente al vero). Qualcuno potrebbe anche pensare: «La chiesa dovrebbe essere uguale al mondo per poter continuare ad avere influenza» (cosa decisamente da evitare). Tali conclusioni sono totalmente fuori strada sul modo con cui l’influenza cristiana ha operato nel corso dei secoli. La chiesa è stata incisiva proprio quando è stata unica. Chiunque si opponesse ai mali del suo tempo, come i giochi dei gladiatori, l’infanticidio, la pederastia o la schiavitù, era reputato pazzo. Tanto più era reputato pazzo per le predicazioni e la teologia su cui si reggevano tali campagne. Nondimeno «lasciarono che la [loro] luce risplendesse davanti agli altri» e la loro diversità si è rivelata incisiva.
Questo è dunque un appello alla chiesa a prendere molto sul serio la propria peculiare unicità. Nell’introduzione ci siamo soffermati sull’acronimo WEIRD utilizzato da Joseph Henrich per descrivere le moderne società e il loro carattere occidentale, istruito, industrializzato, ricco e democratico. Tali società sono state pesantemente influenzate da un certo tipo di cristianesimo. È vero che la nostra civiltà presenta queste caratteristiche. Avviandoci alla conclusione, però, la mia sfida per la chiesa è quella di interpretare in modo corretto tali peculiari caratteristiche. Una tale società sostiene di credere nell’uguaglianza. La
chiesa interpreta in modo corretto questa peculiare caratteristica quando opera per la riconciliazione e l’unità nel momento in cui persone di ogni estrazione giungono a seguire Cristo. Una tale società sostiene di credere nella compassione. La chiesa interpreta in modo corretto questa peculiare caratteristica quando investe nella causa dell’amore. Una tale società sostiene di credere nella libertà. La chiesa interpreta in modo corretto questa peculiare caratteristica quando usa la sua libertà per servire. Una tale società sostiene di essere leale a certi valori. La chiesa interpreta in modo corretto questa peculiare caratteristica quando adora il Cristo cui questi valori appartengono.
In tutto ciò, serve molta saggezza per distinguere i valori cristianofili di una società WEIRD dall’autentico cristianesimo. A volte, un autentico cristianesimo suonerà un po’ troppo “di sinistra” altre volte un po’ troppo “di destra”. Attingendo all’opera dello storico Larry Hurtado, Timothy Keller, leader di chiesa e autore, ha sottolineato come le comunità cristiane nel primo secolo fossero etnicamente eterogenee e radicalmente generose (arrivando al punto, a volte, di custodire i loro beni e il loro denaro in un fondo comune)4. Questo le porrebbe decisamente sul versante di sinistra del nostro attuale panorama politico. Allo stesso modo, si sono strenuamente opposte all’aborto e all’infanticidio e hanno rigorosamente mantenuto la sessualità nell’ambito del matrimonio eterosessuale. Sotto quest’aspetto, le bolleremmo per le loro posizioni di destra.
Questo combinato non passò inosservato neppure allora. Erano oggetto di commenti la grande promiscuità dei cristiani nella loro generosa liberalità e la loro gelosia in tema di sessualità. Il loro denaro era in comune ma lo stesso non valeva per i loro corpi. Tali posizioni sfidavano le categorizzazioni del loro tempo e sfidano anche le nostre. Erano però difficili da definire in quanto non stavano seguendo nessun programma politico. Non erano interessati a essere di sinistra o di destra ma a seguire una chiamata dall’alto: la chiamata di Cristo. È questa la chiamata cui dobbiamo prestare attenzione, la chiamata di cui dobbiamo far risuonare l’eco in tutto il mondo. La proclamazione di Cristo, della sua morte e risurrezione, si è dimostrata straordinariamente potente. La chiesa può trovarsi alle prese con particolari difficoltà nell’occidente secolarizzato ma ci siamo già passati tante volte nel passato. Nel 1925, l’autore G.K. Chesterton scrisse delle tante occasioni nella storia in cui «la chiesa è andata in pasto ai leoni ma in ogni occasione sono stati i leoni a morire». Com’è possibile? «Il cristianesimo è morto molte volte ed è risorto, perché il suo Dio conosceva la via d’uscita dalla tomba»
Il regno di Cristo è unico e non solo per le sue dimensioni e la sua longevità senza precedenti. È diverso in quanto mentre gli altri imperi sorgono e cadono, il regno di Cristo cade e sorge e lo fa molte volte. Ci sono sempre stati degli alti e bassi, mai, però, in quest’ordine. Chiunque sia preoccupato per l’odierna crisi in occidente, può rifarsi a millenni d’ispirazione in rivitalizzanti risvegli. Può, però, anche guardarsi intorno e restare sbalordito dall’attuale crescita nel mondo contemporaneo.
Nel 2060, stando alle previsioni di Pew Research, il cristianesimo si sarà ormai affermato come il più grande credo istituzionalizzato del mondo, avendo continuato a crescere in proporzione alla popolazione mondiale (mentre ateismo e agnosticismo, quelli del “rifiuto” in generale, scenderanno a un tasso compreso fra il 16% e il 13%). Certamente, la composizione della chiesa si sta spostando verso l’est e il sud del mondo e si stima che il 40% dei cristiani di tutto il mondo, in quella fase, saranno africani e che forse metà della Cina sarà diventata cristiana6. Questi sviluppi sono di enorme impatto (anche in considerazione delle dimensioni e dell’importanza della Cina) e dunque, nel considerare i progressi del movimento di Gesù, uno sguardo al cristianesimo su scala planetaria è motivo di grande incoraggiamento.
Oltre a ripercorrere la storia passata e a osservare il mondo intorno a noi, però, dovremmo alzare gli occhi e considerare colui che conosce la via d’uscita dalla tomba. Non abbiamo bisogno di preoccuparci delle dimensioni o delle prospettive della chiesa. Non dovremmo aggrapparci al potere come se fossimo noi a fare la storia. Dovremmo piuttosto confidare nel re del regno e far risplendere la sua luce unica nel mondo. Il futuro non è nelle nostre mani e neppure in quelle dei potenti, delle persone di successo o dei malvagi. Il governo è sulle spalle di Cristo ed egli ha promesso:
«Edificherò la mia chiesa, e le porte dell’Ades non la potranno vincere» (Mt 16:18).
L’articolo A quelli della “riserva” siate unici! 3/3 proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/a-quelli-della-riserva-siate-unici-3-3/
Ti sei sentito ben equipaggiato?
di Andrea Becciolini, Staff GBU Firenze e responsabile Formazione coordinatori.
Una delle domande fatte ai 26 studenti che hanno partecipato al fine settimana di Formazione nazionale (26-29 Settembre) è se si sono sentiti ben equipaggiati per affrontare l’impegno di coordinatore per l’anno accademico a venire. Ringraziamo Dio per come praticamente tutti hanno risposto di sì. E chi ha risposto in altro modo l’ha fatto menzionando due principi che in realtà presentiamo durante la Formazione stessa: la totale dipendenza dal Signore e la natura del processo formativo che dura tutto l’anno accademico a livello locale, in continuità degli input ricevuti durante il fine settimana di Formazione.
Le aree in cui desideriamo equipaggiare gli studenti coordinatori comprendono non solo la capacità (nell’articolare in vangelo, nell’organizzare eventi, nel guidare studi biblici, nel coordinare un gruppo), ma anche e soprattutto la conoscenza sempre più intima di Dio così che maturi in loro un carattere sempre più simile a quello di Cristo. Per questo motivo la Formazione si articola su tre “track”: Conoscere Dio, Coordinare altri, Condividere Gesù. Tre filoni diversi ma interconnessi che puntano allo stesso scopo, quello di vedere studenti testimoni fedeli di Gesù nell’università che guidano altri studenti ad esserlo a loro volta.
I momenti nella Parola di Dio sono dunque fondamentali, sia nello studiarla in gruppetti che nell’ascoltarla predicata. Ringraziamo l’oratore di quest’anno, Domenico Campo (Staff GBU per la Sicilia), per le eccellenti predicazioni da 2 Corinzi 3-5 che ci hanno portati a considerare la verità e le conseguenze legate al fatto che quello stesso Dio creatore che ha detto “splenda la luce nelle tenebre” risplende nei nostri cuori, per far brillare la luce della conoscenza della sua gloria che rifulge nel volto di Gesù Cristo (2 Cor. 4:6). Sì, gli studenti coordinatori sono come vasi di terra del primo secolo, equivalenti a bicchieri di plastica compostabile (è stata una battuta alla Formazione, ndr) del ventunesimo secolo – comuni, fragili, effimeri – eppure hanno in loro stessi il tesoro del vangelo, la gloria del Dio creatore, la luce del Cristo risorto, la presenza dello Spirito Santo, affinché la potenza sia attribuita a Dio e non a loro stessi in quanto semplici ambasciatori del Re dei re.
Queste verità si sono riflesse nei vari seminari, workshop e attività svolte, nella lode, nella preghiera come anche negli gli esercizi evangelistici – una vera e propria uscita evangelistica (avente anche scopo formativo) nel piccolo campus universitario di Rimini, succursale della grande università di Bologna. Come sempre prima di questa uscita ci sono timori, dubbi e perplessità legati non solo al dover approcciare da zero studenti sconosciuti, ma anche sull’effettiva possibilità di incontrarne alcuni. Grazie a Dio tutto ciò è stato spazzato via dal momento in cui siamo arrivati al cancello del cortile del campus, dove tanti studenti erano attorno a dei banchi di benvenuto ufficiale dell’università e dove, dopo poco di mezz’ora, la pausa dalle lezioni ha portato altri studenti, molti dei quali aperti a non solo parlare a riguardo del loro passato spirituale in famiglia e del loro attuale credo, ma anche a fare domande riguardo al cristianesimo e ascoltare il vangelo. Gloria a Dio!
Preghiamo adesso che tutti gli input ricevuti al fine settimana di Formazione Nazionale congiuntamente con il percorso di formazione a livello locale portato avanti dagli Staff GBU sparsi per tutta l’Italia portino frutto alla gloria di Dio nella vita e attraverso la vita degli studenti coordinatori in quanto testimoni fedeli di Gesù nell’università che guidano altri studenti ad esserlo a loro volta.
A quelli del “rigetto” non andatevene! 2/3
Tempo di lettura: 4 minuti
di Glen Scrivener
L’aria che respiriamo. Il cristianesimo, la libertà, l’educazione, il progresso e l’uguaglianza
Edzioni GBU 2025
Ho scritto questo libro rivolgendomi a tre tipologie di lettori [a tre interlocutori]:
Quelli del “rigetto”
Se appartenete alla categoria del “rigetto”, sentite in qualche misura di esservi lasciati il cristianesimo alle spalle. Sapete tutto della fede cristiana. L’avete osservata a fondo e non vi è piaciuto quanto avete visto. Forse in passato siete stati anche profondamente impegnati in chiesa ma ora siete andati o volete andare oltre. Se siete così, vi ringrazio moltissimo per avere preso in mano questo libro e per essere arrivati fin qui. Voglio assicurarvi che posso capire bene le critiche alla chiesa istituzionale. I cristiani onesti dovrebbero esserne pieni e io ne ho
tutto un armamentario. Consentitemi di elencare alcune comuni critiche alla chiesa e di metterle, nel farlo, alla prima persona, perché anche i cristiani hanno problemi con questi temi. Questo, però, è il punto (e non vi sorprenderà sentirmelo dire ancora una volta): ci creano problemi per motivi cristiani.
Se detesto gli episodi in cui la chiesa ha maltrattato le minoranze, sto attribuendo un valore sacrale (e peculiarmente cristiano) ai deboli, ai poveri e agli oppressi.
Se ritengo la chiesa dalla parte sbagliata della storia, sto considerando la storia e il progresso in modi assolutamente biblici.
Se odio l’arrogante colonialismo cui a volte si è accompagnata la crescita della chiesa, sono in linea con ideali profondamente cristiani: chi governa dovrebbe servire, non dominare e le differenze andrebbero valorizzate, non eliminate.
Potrei proseguire.
La litania delle colpe cristiane è lunga. Notate, però, quello che succede anche quando do voce a queste fondate lagnanze. Sto chiamando il potere istituzionale a rispondere delle sue azioni di fronte a un’autorità superiore, sollecitazione incredibilmente biblica. In più, sto confessando dei terribili comportamenti nel nome del cristianesimo istituzionale. Una tale confessione è, di nuovo, profondamente cristiana.
Più di tutto, però, gli standard da me prospettati per il nostro giudizio sono peculiarmente “cristiformi”. Mi sto riferendo a Gesù quale «linea retta» in base alla quale misurare tutte le storture. Quando pertanto la chiesa è giudicata e le sue pecche sono messe a nudo, questa non è un’operazione anti–cristiana. Una riforma radicale e un continuo ravvedimento sono parte integrante del cristianesimo, quanto meno della sua versione più autentica.
John Dickson ricorre all’analogia di una canzone e dei suoi esecutori. Gesù ha donato al mondo una canzone meravigliosa. Il suo popolo, cantandola, l’ha spesso stonata; qualche volta siamo state le voci più stonate di tutte. La canzone, tuttavia, rimane buona e bellissima e se l’avete ascoltata davvero, non riuscirete a togliervela dalla testa.
Lori Anne Thompson è stata forse la principale vittima del famigerato evangelista cristiano Ravi Zacharias. La sua era stata una doppia vita, tanto che perfino al suo funerale, nel 2020, il vice presidente [degli Stati Uniti, ndt] Mike Pence l’ha definito «il più grande apologeta cristiano di questo secolo». In realtà era stato coinvolto per decenni nei più vergognosi
abusi sessuali, spirituali e finanziari. Lori Anne Thompson ha denunciato il modo con cui aveva abusato di lei ma le occorsero anni per essere creduta. La cosa è venuta alla luce solo quando un’ostinata inchiesta dall’esterno mise a nudo le tenebre dell’interno. Il tradimento provato dalla Thompson fu devastante, come svelò nella sua dichiarazione d’impatto della
vittima del 2021:
«Prima di incontrare Ravi Zacharias sapevo che il mondo è un posto insicuro, tuttavia conservavo ancora la speranza nell’esistenza di alcuni spazi sicuri e sacri. Non vivo più con quella speranza. Gli avevo creduto. Avevo creduto nel cristianesimo, una fiducia irreparabilmente e drammaticamente andata in frantumi. Tuttavia, credo ancora in Cristo, anche se magari è una finzione, in quanto non potrei trovare un’etica più alta. Loro (le élite religiose) l’hanno spogliato, percosso senza pietà, insultato in tutti i modi e poi l’hanno anche pubblicamente crocifisso».
Ecco una persona profondamente ferita da autorità e istituzioni cristiane. Tuttavia, la canzone l’ha avvinta. In un certo senso, la canzone è ineluttabile. Se Cristo può essere incontrato e incontrato nel modo più intimo possibile, proprio quando il suo cosiddetto popolo vi disgusta e abusa di voi, allora, come un antico testo scritturale chiede a Dio, «dove fuggirò dalla tua presenza?» (Sal 139:7). Come altrove la Thompson ha detto, «non posso trovare nulla di riprovevole, nulla di falso nella persona di Cristo… Il cristianesimo ha creato dei rifugiati; il Cristo invece li ha accolti».
Da questo punto in poi la strada si presenta simile a quella consigliata a quelli del “rifiuto”: aprire i Vangeli e ascoltare la canzone ancora una volta. Al tempo stesso è fondamentale anche ripristinare la fiducia nella chiesa. Non possiamo sopravvivere con il ricordo di una melodia. Abbiamo bisogno di sentirla suonare. Abbiamo bisogno che prenda vita e si manifesti davanti a noi. La responsabilità di ripristinare la fiducia nella chiesa, però, risiede massicciamente all’interno della chiesa. Per questo voglio finire con una parola rivolta ai cristiani.
L’articolo A quelli del “rigetto” non andatevene! 2/3 proviene da DiRS GBU.
source https://dirs.gbu.it/a-quelli-del-rigetto-non-andatevene-2-3/